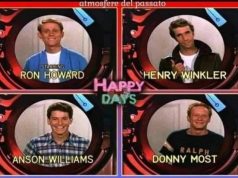Rispetto a JFK, non era rimasta sorpresa. Nell’anno in cui morì c’erano ancora in vita dei texani che avevano visto i genitori scotennati dagli indiani. La terra era assetata. Conservava qualcosa di primitivo.
Benvenuti in Texas, con la sua storia epica e tragica: la guerra con i messicani, la terra strappata agli indiani, le armi che si regalano anche ai bambini e che spuntano ovunque. Frontiera e allevamenti sterminati. Sangue e petrolio.
Tutto questo ci racconta Philipp Meyer in “Il Figlio” (Einaudi), gran libro che ci porta in luoghi degli Stati Uniti meno frequentati dalla grande letteratura e che pure forse dicono di più – o almeno altrettanto – di questo paese che tanti romanzi ambientati a New York o a Los Angeles.
E’ una saga familiare che attraversa tre generazioni, nascita e declino di un impero familiare, fino alla partita finale con il destino. Come quel classico che è i Buddembrook di Thomas Mann, solo in salsa chili. Qui non c’è la buona borghesia di Lubecca, questa è una terra spietata, violenta.
Attenti ai piccoletti, in Texas; devono essere dieci volte più cattivi per sopravvivere in questa terra di giganti.
E spietata, violenta, è anche la trama di questo libro, nel quale però si respira l’aria dei grandi spazi, una singolare libertà. Qui vanno in scena le passioni nel loro stato più puro, senza ipocrisie, senza le lezioni del galateo.
Potenti, i legami del sangue. Solo che può succedere, per le strane traiettorie della vita, che un figlio provi a diventare qualcos’altro. Che siano i libri e non il potere a tentarlo. Che possa persino innamorarsi di una messicana…