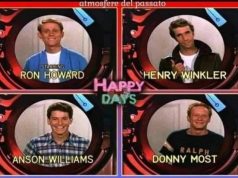Se lo chiedono in tanti, fuori e dentro il partito. Qualche tempo fa se lo chiese su l’Unità (o ciò che ne rimane), con l’autorevolezza dell’intellettuale e del politico di rango, anche Alfredo Reichlin: «Si vuole consolidare il PD come un grande campo che organizza e unisce le forze progressiste sia di centro che di sinistra? Oppure, volenti o nolenti, si scivola verso un nuovo partito orientato al centro capace di assimilare pezzo a pezzo la parte meno indigesta della destra, e ciò in quanto fonda il suo asse di governo su una base culturale e morale che rinnega e sola la sostanza del patrimonio storico della sinistra italiana».
Se lo chiedono in tanti, fuori e dentro il partito. Qualche tempo fa se lo chiese su l’Unità (o ciò che ne rimane), con l’autorevolezza dell’intellettuale e del politico di rango, anche Alfredo Reichlin: «Si vuole consolidare il PD come un grande campo che organizza e unisce le forze progressiste sia di centro che di sinistra? Oppure, volenti o nolenti, si scivola verso un nuovo partito orientato al centro capace di assimilare pezzo a pezzo la parte meno indigesta della destra, e ciò in quanto fonda il suo asse di governo su una base culturale e morale che rinnega e sola la sostanza del patrimonio storico della sinistra italiana».
Il Pd vuole davvero trasformarsi nel cosiddetto “partito della nazione” che occupa, con un occhio a destra, il centro dell’arena politica, e che conseguentemente si fa rappresentante di un blocco sociale soprattutto moderato; oppure è solo il momento eccezionale che richiede di tenere la barra ovunque tranne che a sinistra? È la contingenza di un Governo di larghe intese e d’emergenza istituzionale, sostenuto anche dal centrodestra, che impone suo malgrado a Renzi certe politiche economiche e certi messaggi che spesso ripercorrono programmi cari alle vecchie coalizioni della libertà di berlusconiana memoria? Oppure il Segretario vuole davvero fare delle larghe intese un progetto politico? Con il PD che diventi levatrice di una Terza Repubblica nella quale l’unica alternativa sia quella tra il partitone che tutto include e il populismo del M5S, e tutto il resto relegato fuori dallo schema a rincorrere inutilmente l’astensionismo. Il PD delle larghe intese è solo una parentesi indigesta o il preludio di un lungo romanzo? Insomma il PD c’è o ci fa?
 Ci sono due caratteristiche del renzismo che possono aiutare a trovare una risposta. La prima è che esso, per sua natura, non pare ammettere la sconfitta. La sua affermazione sulla scena politica dipende soprattutto dal fatto che si presenta con una sorta di alone di infallibilità che lo mostra invincibile in ogni competizione esterna o interna al partito. Con Renzi si vince, sempre. Questa la percezione collettiva che diventa spesso anche motivo di una sorta di sospensione di giudizio, di un’adesione aprioristica, in nome del fatto che, dopo tanto aver perso, con Renzi finalmente si possa vincere. Si può tollerare tanto, si può accettare anche ciò che non si condivide, se si crede che in cambio arrivi, dopo tante delusioni, la soddisfazione di prevalere sugli avversari. «Finalmente ho fatto una cosa di sinistra: ho perso!», disse Renzi sconfitto alle primarie con Bersani del 2012. Che vera sconfitta poi non fu, appunto, nessuno l’avvertì come tale, un po’ perché prevista, un po’ perché forse anche auspicata, viste le peste nelle quali si sarebbe trovato il vincitore. E infatti quelle primarie risultarono poi essere solo il tampolino di lancio servito da Bersani a Renzi su un piatto d’argento in deroga allo statuto.
Ci sono due caratteristiche del renzismo che possono aiutare a trovare una risposta. La prima è che esso, per sua natura, non pare ammettere la sconfitta. La sua affermazione sulla scena politica dipende soprattutto dal fatto che si presenta con una sorta di alone di infallibilità che lo mostra invincibile in ogni competizione esterna o interna al partito. Con Renzi si vince, sempre. Questa la percezione collettiva che diventa spesso anche motivo di una sorta di sospensione di giudizio, di un’adesione aprioristica, in nome del fatto che, dopo tanto aver perso, con Renzi finalmente si possa vincere. Si può tollerare tanto, si può accettare anche ciò che non si condivide, se si crede che in cambio arrivi, dopo tante delusioni, la soddisfazione di prevalere sugli avversari. «Finalmente ho fatto una cosa di sinistra: ho perso!», disse Renzi sconfitto alle primarie con Bersani del 2012. Che vera sconfitta poi non fu, appunto, nessuno l’avvertì come tale, un po’ perché prevista, un po’ perché forse anche auspicata, viste le peste nelle quali si sarebbe trovato il vincitore. E infatti quelle primarie risultarono poi essere solo il tampolino di lancio servito da Bersani a Renzi su un piatto d’argento in deroga allo statuto.
Ma quelle parole racchiudono un’idea che si è poi consolidata: alla parola sinistra si associa la sconfitta, lo stare fuori dalle stanze del potere, la mera testimonianza politica. Alla parola Renzi la vittoria. Lo stesso Renzi che ripete come un mantra «se perdo vada a casa», dando per scontato che non sia suo onere garantire alcun «se perdo mi preparo per vincere la prossima volta», ha ben capito che la sconfitta non fa parte, nemmeno parzialmente, di ciò che è nelle sue disponibilità. Il renzismo non pare poter cadere e rialzarsi, perché dopo una sconfitta si ritroverebbe nudo di fronte alla normalità, si sgonfierebbe della sua straordinarietà, della sua professata unicità e infallibilità. Entrerebbe a far parte anch’esso, nell’immaginario collettivo, della serialità dei fenomeni politici che in Italia si accendono e si consumano in una breve stagione. Diventerebbe vecchio in un istante. La seconda caratteristica, in parte conseguenza della prima, ma anche retaggio dell’eredità democristiana, è che il renzismo sembra avere un senso politico solo nella dimensione di governo. Il renzismo all’opposizione non ha ragione d’essere, nemmeno temporaneamente. Con la conseguenza che è spinto a muoversi in base al principio (qui l’insegnamento D.C.) che l’importante è esserci, in qualche modo sempre e comunque, lì dove si decide. Il resto non conta, e dunque se per esserci occorre smentirsi, contraddirsi, scendere a compromessi impensabili il giorno prima, perdere pezzi di partito, dispiace (forse) ma occorre superare l’imbarazzo (se c’è) in nome dell’unico vero obiettivo che dia un senso al fare politica, ovvero entrare nella stanza dei bottoni.
 Perché se non sei dove si decide, non sei e basta. Coerente tutto ciò con l’esaltazione renziana della politica del “fare” rispetto a quella definita delle chiacchiere, delle lunghe discussioni, dei convegni, dei professoroni: se sei all’opposizione che cosa puoi fare? Niente, solo perdere tempo. Nella visione renziana se non sei chiamato a decidere, se non sei tu a tirare le fila ora e subito, o comunque se non ti trovi almeno con un piede dentro i luoghi in cui le fila si tirano, non servi a nulla. Immagino che adesso vi aspetterete la logica conclusione, ovvero che sono tutte caratteristiche che portano dritti dritti al partito della nazione senza fermate intermedie. Al partitone che sta nel mezzo e che occupa tutto quello che può occupare, che si fa tutto e solo collettore di potere e di poteri; una macchina da elezioni che, come la fu DC, usa l’apparato dello Stato per consolidare il consenso, per vincere e governare costi quel che costi. Ma non l’avrete. Mi fa troppo male.
Perché se non sei dove si decide, non sei e basta. Coerente tutto ciò con l’esaltazione renziana della politica del “fare” rispetto a quella definita delle chiacchiere, delle lunghe discussioni, dei convegni, dei professoroni: se sei all’opposizione che cosa puoi fare? Niente, solo perdere tempo. Nella visione renziana se non sei chiamato a decidere, se non sei tu a tirare le fila ora e subito, o comunque se non ti trovi almeno con un piede dentro i luoghi in cui le fila si tirano, non servi a nulla. Immagino che adesso vi aspetterete la logica conclusione, ovvero che sono tutte caratteristiche che portano dritti dritti al partito della nazione senza fermate intermedie. Al partitone che sta nel mezzo e che occupa tutto quello che può occupare, che si fa tutto e solo collettore di potere e di poteri; una macchina da elezioni che, come la fu DC, usa l’apparato dello Stato per consolidare il consenso, per vincere e governare costi quel che costi. Ma non l’avrete. Mi fa troppo male.