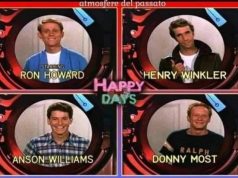Bello, non bellissimo. O forse quasi bello, in realtà così e così. O forse un capolavoro. Un capolavoro che non incanta e non cattura. O forse sì, solo bisogna prenderlo per il verso giusto, a trovarlo il verso…
Bello, non bellissimo. O forse quasi bello, in realtà così e così. O forse un capolavoro. Un capolavoro che non incanta e non cattura. O forse sì, solo bisogna prenderlo per il verso giusto, a trovarlo il verso…
Non è facile fare i conti con “L’ultimo inverno” di Paul Harding (Neri Pozza), con il suo fascino scontroso, con la sua raffinatezza da circolo esclusivo, con la sua bellezza che è la bellezza delle montagne più ripide, di cui fino all’ultimo non sai mai se arriverai fino alla cima.
La storia è bella, intrigante, commovente. C’è George, il riparatore di orologi (riparare orologi significa anche riparare il tempo?), inchiodato dalla malattia a letto, per l’ultimo inverno di una vita da ripercorrere all’indietro. C’è Howard, che di George è il padre, con la sua vita di venditore ambulante malato di epilessia, uomo di abbandoni e fughe e incontri straordinari. C’è l’America che non è l’America di New York e di Los Angeles, ma è l’America del New England, foreste e villaggi. C’è il silenzio che è anche il silenzio maestoso della natura, solo che quel silenzio si impasta con il ticchettio degli orologi. C’è un padre e c’è un figlio e sono due persone che sembrano destinate a non incontrarsi mai, solo che non si può dire, solo che in definitiva c’è sempre tempo….
Un capolavoro? Forse o forse no. Meritava il Pulitzer? Forse o forse no. Un libro importante, sicuramente, per quanto voglia dire. Un libro di emozioni a cui forse manca proprio l’emozione della scrittura, soffocata da eccessi stilistici e forse da qualche lezione di troppo di scuola creativa.