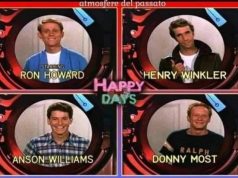Di Torino amo la pianta a scacchiera, i lunghi viali alberati, i portici luminosi ed eleganti, le grandi piazze (Piazza Castello, Piazza San Carlo, Piazza Carignano) sulle quali si affacciano chiese e palazzi in stile barocco. Nessuna città più del capoluogo piemontese rappresenta per me un incessante invito alla passeggiata lenta, rilassata, quella che non costringe ad alzare gli occhi al cielo per sincerarsi che le nuvole che si sono formate non portino la pioggia. Dovesse anche iniziare a piovere, infatti, io potrei continuare a muovere tranquillamente i miei passi sotto i portici – che si estendono per 18 km – o entrare in uno dei tanti caffè storici, che sembrano riportare indietro le lancette della Storia, senza dover mutare di una virgola i miei programmi o le mie abitudini. Torino è veramente un immenso e regale salotto.
I salotti, però, intendo i salotti di un’abitazione, hanno sempre una o più porte. Quando la festa è terminata, quando la riunione si è conclusa, gli ospiti vengono accompagnati all’ingresso e i battenti vengono serrati. Nessuno vi entra più, tranne i padroni di casa. A loro capita, può capitare. Magari si accorgono di avere dimenticato gli occhiali da vicino sul tavolo oppure hanno voglia di sorseggiare un po’ di quel buon rhum riposto nell’armadietto dei liquori. A quel punto escono dalla cucina – fuori è già buio da ore – o si alzano dal letto, raggiungono il salotto, aprono la porta, accendono la luce – l’interruttore rimane sulla sinistra, anche a tastoni si trova bene – entrano nella stanza. Fanno quello che devono fare e poi riescono. I salotti di casa hanno sempre una o più porte, che si lasciano spalancare e si lasciano richiudere, magari anche a doppia mandata. Esse uniscono e dividono.
Ma una città, una città-salotto (al di là del fatto che appare discutibile la distinzione tra chi può essere detto padrone della stessa e chi no), non ha porte, non può averne, a eccezione di quelle urbiche, vale a dire di quelle che fanno (più spesso facevano) parte della cinta muraria che circonda il centro abitato. Porta Maggiore a Orvieto, Porta Camollia a Siena, Porta Paola a Ferrara, Porta Monterone a Spoleto ne sono un esempio. Le porte urbiche, però, sono porte molto particolari. Monumentali, decorati, spesso fortificati, tali accessi, infatti, hanno costituito a lungo il discrimen tra l’interno e l’esterno, il dentro e il fuori. Oggi, però, in conseguenza dell’ingrandimento dei centri abitati, tali porte non si trovano più dove la città ha inizio o ha fine, dove, in sostanza, furono progettate e costruite. Sono state inglobate, sono state circondate da edifici, talora perfino da quartieri, smarrendo così la funzione originaria, reale e simbolica, di separare, di delimitare. No, una città non ha porte, non può averne, se anche quelle che un tempo lo furono, lo furono per davvero, ormai sono divenuti semplici monumenti, da osservare e fotografare.
E così neppure Torino, quando si fa sera, quando le serrande dei negozi vengono abbassate, può con un giro di chiavi impedire che uomini e donne continuino a fare il loro ingresso e a sostare sotto i portici, quei bellissimi portici, che del salotto cittadino costituiscono l’espressione più manifesta, compiuta, perfetta. L’arrivo di queste persone non è del tutto inatteso, del tutto sorprendente. Alcune di loro, infatti, già al mattino stavano sedute per terra, la schiena appoggiata contro il muro, le gambe coperte da un plaid, in bocca un mozzicone spento. Altre, in piedi, fuori dai negozi, reggevano con una mano un piccolo bicchiere di plastica, nell’altra tenevano una sacca di tela, lisa, sporca. E poi c’erano quei cartoni spessi, ripiegati alla meno peggio e in parte nascosti alla vista, che lasciavano intendere che qualcuno doveva servirsene come giaciglio di fortuna. Anche un carrello della spesa con una ruota rotta, qualche busta dell’immondizia dalla quale uscivano indumenti impossibili da riconoscere, due ciotole per cani, erano i segni inequivocabili della presenza continuata di senzatetto in quegli spazi. Una presenza, però, che la folla, il rumore, il lavoro, le incombenze quotidiane fanno presto scivolare tra le cose che non contano, sulle quali non è dato soffermarsi. Intraviste e subito dimenticate.
Ma quando si fa buio, è diverso, quando si fa buio e passeggio sotto i portici di Torino, è completamente diverso. Perché i cartoni sono diventati veramente un letto, perché sotto le coperte quella che si lascia scorgere è veramente la sagoma di un uomo, perché quelli allineati sulla pagina sgualcita di un quotidiano sono veramente poveri effetti personali (un pettine, un coltello, un fazzoletto per la testa, un berretto di lana). Sono uomini italiani, sono uomini stranieri, perché la povertà, al pari della ricchezza e della morte, non fa distinzioni. Sono uomini. Di giorno molti di loro sono stati in un centro di accoglienza e hanno mangiato alla mensa dei poveri. Hanno scambiato qualche parola tra di loro e con i volontari, come è mostrato anche nel bellissimo film di Giovanni Bedeschi “Pane del Cielo”, splendidamente interpretato da Donatella Bartoli e Sergio Leone (Lilli e Annibale) e ambientato nell’universo dei senza dimora milanesi. Questi uomini sono riusciti anche a ridere o, almeno, a sorridere. C’è pure chi ha chiesto loro se il mal di denti si fosse un poco attenuato o gli ha riferito i risultati della giornata di campionato di calcio. In un dormitorio, però, non vogliono andare, perché temono che le poche cose che hanno gli vengano rubate. O forse perché non si può vivere passando in continuazione da un posto all’altro senza avere la possibilità di riconoscere un angolo come il proprio, sempre quello, sempre lo stesso. E infatti i senzatetto di Torino, così come i senzatetto di qualunque altra città, amano sempre occupare per dormire la medesima porzione di suolo, quasi che fosse la loro camera, la loro stanza. Forse si mettono d’accordo, forse c’è fra di loro una tacita intesa. Ma non è possibile tirare avanti senza l’opportunità di dire qualche volta “questo è mio”, “questo appartiene a me”.
Nella prossimità dei giacigli ai negozi che si aprono sotto i portici colgo qualcosa di drammatico. Ancor meglio, rinvengo tutta la drammaticità della verità. Perché la verità è sempre drammatica, sia quando si parla di Dio sia di quando si parla dell’uomo. Qual è, dunque, la verità che tale vicinanza spaziale – la “camera” degli homeless e l’esercizio commerciale – ci suggerisce? La più semplice – spesso la verità lo è – vale a dire che i poveri del terzo millennio ancor prima che disoccupati, mendicanti, alcolizzati, asociali, violenti, oziosi, sono dei mancati consumatori. Dentro i negozi entrano coloro che dispongono di un reddito ed è tale disponibilità a renderli necessari e desiderati dalla società: acquistano, spendono, rispondono alle continue tentazioni del mercato dei beni materiali. Fuori dai negozi, a volte di giorno, quasi sempre di notte, rimangono coloro che consumatori lo furono un tempo, ma che ora non lo sono più. Perciò non appaiono necessari, non sono desiderati. Spesso sono guardati con fastidio, si vorrebbe allontanarli, costringerli in uno spazio distante mille miglia da quello frequentato dal “buon mercante inteso alla moneta”, come avrebbe scritto Guido Gozzano. A volte si adducono ragioni di decoro (non è una bella immagine per la città), altre volte ragioni umanitarie (in un dormitorio patirebbero meno freddo). La verità è un’altra. Ed è che tutte quelle esistenze mancate, bloccate, violentate, che ci vengono incontro sotto i portici, nelle stazioni dei treni e della metropolitana, al riparo di un cavalcavia cittadino, ci ricordano la scandalosa ingiustizia di un sistema economico e sociale, il nostro, quello mondiale, dove a contare sono unicamente l’utilità, il profitto, il consumo. Ma se ancora siamo capaci di provare vergogna di noi stessi e di ciò che siamo diventati, allora non tutto è perduto. Se poi ci prende la paura che un giorno anche noi potremmo trovarci nelle stesse condizioni, allora c’è ancora speranza. Non conosco, infatti, un sentimento che più della vergogna e della paura possa trasformare la persona, farle acquisire consapevolezza che il nostro “stare troppo bene” poggia sullo “stare troppo male” di qualcun altro.