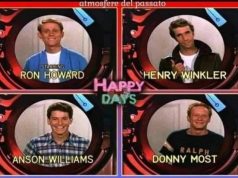La strada che da Cracovia conduce a Oświçim (in tedesco Auschwitz) è una strada per lo più rettilinea e a due corsie. Soltanto per brevi tratti si piega in morbide curve e unicamente in prossimità della città, che dal 1038 al 1596 fu la capitale della Polonia, diviene a quattro corsie. La breve distanza – poco più di sessanta chilometri – e l’assenza quasi completa di traffico, consentono di raggiungere col pullman in poco più di un’ora Auschwitz, nei pressi della quale i nazisti costruirono il più grande campo di concentramento, di lavoro forzato, di sterminio della Seconda Guerra Mondiale.
Mentre col mio gruppo mi dirigo verso il piazzale dove abbiamo l’appuntamento con la guida, so già che né i documentari e i film che ho visto né i libri che ho letto, dedicati alla Shoah, mi potranno essere di alcun aiuto. Neppure “Se questo è un uomo” di Primo Levi o “La notte” di Elie Wiesel o “La scena interiore” di Marcel Cohen. In nessun luogo come ad Auschwitz, infatti, la parola sperimenta maggiormente la propria insufficienza, si tratti pure della parola soppesata, meditata, scelta, della parola, cioè, che si fa opera d’arte. Tra la storia e il racconto, tra quanto è accaduto e quanto viene riferito, sussiste una distanza che non c’è buona volontà o capacità espressiva che sappiano accorciare o colmare. A tal punto varcare il cancello di Auschwitz (Auschwitz I, luogo di concentramento, e Auschwitz II, distante tre chilometri, luogo di sterminio di massa del popolo ebraico), dove trovarono la morte tra il 1940 e l’inizio del 1945 più di 1.100.000 persone, comporta che si entri nei territori dell’indicibile.
La “soluzione finale della questione ebraica” fu concepita e pianificata nel cuore della vecchia Europa, nella patria di Goethe e di Schiller, nel paese dove più si conservava viva la grande tradizione degli studi di filologia classica. A metterla in pratica furono uomini che avevano confidenza con i capolavori della filosofia antica e moderna, che amavano la musica di Mozart, che erano stati educati alla “civiltà delle buone maniere”. Ma di fronte alla malvagità di cui l’essere umano è capace, non c’è – non ci fu – libro, concerto, dipinto, fregio, gruppo scultoreo, che possa contenerla, che possa neutralizzarla. Ed espressioni come humanitas, umanesimo, studia humanitatis, risuonano – risuonarono – più false di una moneta di pessimo conio. A conferma che esiste una legge non scritta, ma imperiosa al pari di un comando, la quale esige che l’uomo, quando può compiere il male, lo compia, sempre e comunque, mentre se può compiere il bene, a volte lo fa, altre volte si astiene dal farlo. No, la “soluzione finale della questione ebraica” non fu, come pensava anche Hannah Arendt, un inciampo lungo il cammino della modernità, la quale, nel suo incessante avanzare, è destinata a debellare la barbarie; piuttosto, essa fu l’espressione di una delle possibilità più vere dell’uomo, il quale può venire descritto correttamente solamente a patto di partire da una correlazione (“e la civiltà e la barbarie”), e non da una contrapposizione (“o la civiltà o la barbarie”). L’eliminazione sistematica di 1.100.000 persone, infatti, non fu la conseguenza di una ragione sonnacchiosa o dormiente, ma, al contrario, ben sveglia, vigile, educata, che nel corso della Conferenza di Wannsee giunse a concepire l’idea di eliminare un intero popolo e di edificare ambienti deputati esclusivamente a questo scopo.
Visitare Auschwitz comporta per la mente un grande sforzo, uno sforzo enorme, quello di andare oltre il concetto di quantità, un concetto che rischia di sopraffare il visitatore ad ogni istante. Perché un milione di morti è una cifra veramente difficile da concepire. Non è una misura, è una dismisura. L’eliminazione sistematica di un milione di persone, dopo avere smembrato ogni nucleo familiare, dopo avere trasformato in un addio definitivo il saluto scambiato, su una gelida banchina, tra un marito e una moglie, un padre e una figlia, un fratello una sorella – anche a Elie Wiesel toccò questo in sorte nel 1944, all’età di soli sedici anni– è un’azione che, al pari di un paesaggio troppo vasto, o non si riesce ad afferrare nella sua interezza o non ci consente di cogliere la ricchezza molteplice e preziosa degli elementi che lo compongono. A quel punto, si finisce per non capire quanto si osserva. Si distoglie lo sguardo, lo si ritrae, lo si posa su realtà più vicine, più familiari, le quali, proprio perché più familiari, risultano meno spaesanti. Si torna a contare, si torna a enumerare, a sentirsi a casa propria, perché la misura, non la dismisura, è, per l’uomo occidentale, almeno da Socrate in poi, la dimora del pensiero.
Eppure, gli occhi devono continuare a cercare Auschwitz, devono fissare, al di là dei grandi vetri di alcune sale di Auschwitz I, la valigia, la teiera, la tazza, il pettine, le ciabatte, il paio di scarpe, e lo devono fare con la consapevolezza che ciascuno di quegli oggetti appartenne a un individuo in carne ed ossa, unico, inconfondibile, irripetibile come lo è ciascun individuo, come lo era ciascuna di quelle 12.000 persone che quotidianamente venivano uccise, venivano ridotte a cadaveri gonfi e rigidi come blocchi di basalto. Ripercorrere il cammino all’inverso. Questo occorre fare. Attraverso il pensiero. Per mezzo dell’immaginazione. Questo esige Auschwitz. Che si osservi, cioè, quel singolo manufatto, ad esempio, quel paio di scarpe numero 33, e si torni con la mente al giorno in cui vennero acquistate, in una bottega polacca o ungherese, dopo che la bambina ne aveva provati alcuni modelli sotto lo sguardo attento della madre e di una commessa. Le aveva calzate con la certezza che dopo quelle ce ne sarebbero state tante altre di scarpe nella propria esistenza, via via che gli anni passavano e il piede cresceva, via via che le occasioni per indossarle, mostrarle, cambiarle, aumentavano. E poi sarebbe venuto il momento – per quella bambina, per molte altre bambine – di partire per un viaggio col proprio sposo, magari dopo avere sistemato i vestiti dentro la valigia di pelle nera, che la madre aveva ereditato dal nonno e che recava impressa a grandi lettere la scritta con l’indirizzo della ditta paterna, quella stessa valigia di pelle nera che pare cercare il mio sguardo, al pari di quello dei visitatori di Auschwitz I, in questa fredda giornata di inizio dicembre del 2018. Perché è di questo e non di altro che ci parlano quegli oggetti ora ammassati dietro gli ampi vetri di queste sale spaziose, vale a dire di una normalissima quotidianità, che però non ci fu, non ci fu mai. Essa fu negata, bruciata, dispersa nell’aria insieme alla cenere dei cadaveri, insieme a nomi e cognomi sostituiti da numeri, molte volte da niente. E tutto ciò venne concepito e pianificato nel cuore della Vecchia Europa, dove l’ouverture dei Maestri cantori di Norimberga di Wagner risuonava un po’ ovunque durante le manifestazioni ufficiali del Partito Nazionalsocialista e mentre nelle università tedesche si leggevano gli studi che Wilamowitz-Moellendorff aveva dedicato a Pindaro e a Platone.
La cultura, questa è la verità, non può niente contro la cattiveria dell’uomo. Auschwitz non fu un semplice inciampo lungo il cammino della modernità e della civiltà. Se esso fu, come recita il titolo di un libro di Hannah Arendt “L’immagine dell’inferno”, è perché l’inferno l’uomo lo reca dentro di sé, da qualche parte, laggiù nel profondo.