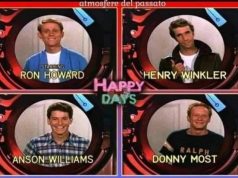«L’astensione è un fatto secondario, ciò che conta è che abbiamo vinto 2 a 0». Così il Segretario del PD Matteo Renzi dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Una dichiarazione che ha percorso la schiena di molti iscritti e militanti del PD, soprattutto quelli “old style”, come un filo d’olio bollente. Perché, al di là della necessità contingente dopo ogni elezione di sottolineare gli elementi positivi e minimizzare quelli negativi, c’è molto di più dietro quelle parole, c’è un’intera concezione del partito politico che marca una cesura netta tra due visioni distinte della politica. C’e la differenza tra quello che viene definito “partito elettorale” da una parte e il “partito valoriale” dall’altra. Si badi bene non c’entra nulla in questo contesto il partito “comitato elettorale”, quello è un altro problema e attiene all’assenza di esso al di fuori dei momenti elettorali.
«L’astensione è un fatto secondario, ciò che conta è che abbiamo vinto 2 a 0». Così il Segretario del PD Matteo Renzi dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Una dichiarazione che ha percorso la schiena di molti iscritti e militanti del PD, soprattutto quelli “old style”, come un filo d’olio bollente. Perché, al di là della necessità contingente dopo ogni elezione di sottolineare gli elementi positivi e minimizzare quelli negativi, c’è molto di più dietro quelle parole, c’è un’intera concezione del partito politico che marca una cesura netta tra due visioni distinte della politica. C’e la differenza tra quello che viene definito “partito elettorale” da una parte e il “partito valoriale” dall’altra. Si badi bene non c’entra nulla in questo contesto il partito “comitato elettorale”, quello è un altro problema e attiene all’assenza di esso al di fuori dei momenti elettorali.
Qui parliamo di un modello di partito che fa della vittoria elettorale la sua unica o comunque preponderante missione, contrapposto ad un altro modello che si propone invece di affermare i propri valori nella società, a costo di rinunciare al potere reale e di fare solo opera di testimonianza etico-politica. Ovviamente un partito non sarà mai solo l’una o l’altra cosa, sono due estremi ideali all’interno dei quali ci si muove. Per usare una metafora calcistica, tipologia di metafora che nella politica italiana ormai è diventata una Stele di Rosetta, potremmo dire che nella maggioranza dei casi se la tua squadra vince te ne importa poco se il rigore che ti hanno dato non c’era o se hai segnato con una mano, l’importante è vincere. Poi invece c’è chi parla di fair play e di bel gioco a costo anche di perdere. Due visioni che muovono da presupposti profondamente diversi, da risposte speculari alla seguente domanda: i partiti devono rappresentare la società o devono cambiarla in meglio?
Da qui discende tutto il resto, e da qui discende anche quel grado di incomunicabilità che taglia in due come una faglia tettonica il mondo PD, dall’Assemblea Nazionale in giù, fino al più sperduto dei Circoli. Un nuovo militante che dice «il mondo è cambiato, prendiamone atto» e un altro che risponde «noi siamo qui anche per cambiarlo il mondo», possono stare ore a parlare, ma difficilmente si capiranno davvero. Tra chi dice «i cittadini questo vogliono, e dobbiamo accettarlo e darglielo altrimenti non ci votano», e chi risponde «noi dobbiamo trasmettere valori ai cittadini, insegnare qualcosa loro, anche a costo di essere minoritari», il tutto finisce a guardarsi l’un l’altro come sulla Torre di Babele dopo la maledizione divina. Linguaggi incomprensibili gli uni agli altri.
E anche l’astensione diventa secondaria nel primo tipo visione se consente comunque la vittoria, mentre è una vittoria mutilata se il partito si propone di permeare di sé idealmente la società. Perché il PD di Renzi oggi è soprattutto un partito elettorale. Quel “pragmatismo” di cui il fenomeno renziano si è fatto orgogliosamente portatore, contrapponendolo, nella propria narrazione della realtà, all’inconcludenza narcisistica e logorroica di una sinistra statica tutta convegni e documenti, una volta ottenuta la guida del partito in questo si è tradotto, nell’affermazione del partito della vittoria. Trovando certo terreno fertile in una tradizione della sinistra italiana che pareva rappresentare l’ineluttabile vocazione alla sconfitta; sconfitta che perdeva perfino parte dei suoi connotati negativi, agli occhi degli sconfitti medesimi, se associata alla rinuncia esemplare a scendere a compromessi con i propri valori e ideali.
E dentro queste due visioni del partito stanno anche due visioni diverse della democrazia: l’una di stampo tendenzialmente più liberale, che pone l’accento sulla rappresentanza; l’altra di stampo tipicamente democratico, che pone l’accento sulla partecipazione. Nella prima il momento decisivo sta nell’individuazione di “chi decide”, nella legittimazione del processo attraverso il quale il delegante sceglie il delegato. Il massimo coinvolgimento, la partecipazione popolare, devono manifestarsi nel momento in cui si è chiamati a stabilire “chi” deve assumere decisioni per nostro conto, chi deve rappresentarci. E di qui le primarie come momento di massima partecipazione democratica e investitura del leader. Nella seconda invece il momento decisivo sta nel “cosa si decide”. La partecipazione al percorso decisionale, sulla base del principio democratico, non solo è diritto da garantire, ma è essa stessa garanzia che la decisione assunta sia migliore. Più teste partecipano a decidere, e non solo maggiore sarà la valenza democratica della decisione, ma più adeguata ed efficace sarà la deliberazione. E di qui la rivendicazione del ruolo degli organismi, degli iscritti, dei circoli. Anche in questo caso due estremi ideali, ma non c’è dubbio che in questo PD la visione che appare dominante è quella del leader che chiede e assume su di sé la delega, attraverso un metodo democratico e collettivo, che poi legittimerebbe però un minor grado di democraticità nel percorso decisonale, perché il decisore stesso trasferisce legittimità alla decisione.
Sono questi i due universi del PD oggi, l’uno dominante l’altro a rincorrere, parlando lingue diverse. L’uno con la forza dei numeri e del consenso, ma la debolezza potenziale di non ammettere per definizione, di non contemplare, la possibilità della sconfitta: perché nel partito elettorale o sei vincente o non sei. Il «se falliamo noi, fallisce l’Italia» di Renzi, per capirci. L’altro con la debolezza di una tradizione minoritaria, ma la forza della persistenza, perché nel partito valoriale si può anche perdere se hai contribuito a cambiare comunque un angolo di mondo. Il «dopo di me c’è il PD» di bersaniana memoria.
Riusciremo ad inventarci un “esperanto” che permetta al PD di ricomporsi in un lessico condiviso? Riusciremo a trovare un punto di caduta comune tra la necessità di vincere, e quella di dare uno scopo ideale alla vittoria?