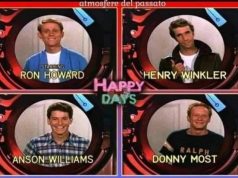Grazie al combinato disposto della legge che ha introdotto nel 1993 l’elezione diretta e della disgrazia in cui sono caduti i partiti con Tangentopoli, i Sindaci hanno occupato, ormai più di venti anni fa, il centro della scena politica.
Grazie al combinato disposto della legge che ha introdotto nel 1993 l’elezione diretta e della disgrazia in cui sono caduti i partiti con Tangentopoli, i Sindaci hanno occupato, ormai più di venti anni fa, il centro della scena politica.
In questi due decenni hanno svolto un ruolo “altro” rispetto a partiti ormai evaporati, operando con un elevato grado di autonomia decisionale nei propri territori, ma non solo, facendo anche della loro posizione un trampolino di lancio per ben più prestigiosi incarichi nazionali.
Evento del tutto naturale in un contesto nel quale le candidature e le elezioni a Sindaco solo in minima parte sono dipese dai partiti, essendo state soprattutto legate al prestigio e al consenso personale degli interessati, e ciò già ben prima dell’avvento delle primarie. E considerando poi che anche la buona riuscita dei mandati amministrativi, o comunque la loro percezione da parte dei cittadini, poco hanno avuto a che vedere con il sostegno proveniente dai partiti; anzi in alcuni casi averli contro ha rappresentato un motivo di ulteriore consenso, in un’ottica antipartitica e di esaltazione del ruolo della società civile.
Il più o meno stretto legame del Sindaco col partito, la presenza di una dialettica tra le due dimensioni, sono stati più determinati dalle singole volontà dei primi cittadini, dalla loro propensione o meno a garantire la condivisione delle scelte, che non da una reale esigenza di avere i partiti dalla propria parte.
Renzi e il renzismo hanno portato all’estrema conseguenza questo processo, con il Sindaco di Firenze balzato in tre mesi a fare il Segretario del primo partito italiano ed il Presidente del Consiglio poi; e con il PD programmaticamente proiettato a diventare il “partito dei Sindaci”, opzione uscita vincente dal congresso insieme alla figura di Renzi.
Sindaci dunque che non solo si rendono autonomi dal partito ma, nel caso del PD, arrivano proprio a mangiarselo: diventano “il” partito, lo inglobano, lo inghiottono.
 Accade però poi un fatto ulteriore, e cioè che con Renzi non prende corpo solo il partito dei Sindaci, ma anche il “partito della maggioranza” e soprattutto del leader. Il partito in cui il ruolo di Segretario Nazionale, e a caduta tutte le altre cariche monocratiche territoriali, dai Segretari regionali ai coordinatori di Circolo – salvo eccezioni dovute alle attitudini personali di ognuno piuttosto che al sistema in sé – perdono ogni connotato di sintesi tra la cosiddette varie sensibilità del partito, e dunque anche di garanzia delle minoranze e più in generale del dissenso, per dedicarsi esclusivamente all’attuazione del programma congressuale risultato vincente, senza mediazione alcuna e senza pietà per i vinti. Programma nel caso di Renzi più intuibile che non esplicitato durante il Congresso, e che si è reso poi evidente in corso d’opera.
Accade però poi un fatto ulteriore, e cioè che con Renzi non prende corpo solo il partito dei Sindaci, ma anche il “partito della maggioranza” e soprattutto del leader. Il partito in cui il ruolo di Segretario Nazionale, e a caduta tutte le altre cariche monocratiche territoriali, dai Segretari regionali ai coordinatori di Circolo – salvo eccezioni dovute alle attitudini personali di ognuno piuttosto che al sistema in sé – perdono ogni connotato di sintesi tra la cosiddette varie sensibilità del partito, e dunque anche di garanzia delle minoranze e più in generale del dissenso, per dedicarsi esclusivamente all’attuazione del programma congressuale risultato vincente, senza mediazione alcuna e senza pietà per i vinti. Programma nel caso di Renzi più intuibile che non esplicitato durante il Congresso, e che si è reso poi evidente in corso d’opera.
Da qui un partito che, per scelta esplicita e manifesta, si immedesima e si risolve tutto, tra un Congresso ed un altro, nella stessa maggioranza che lo governa, con le minoranze relegate ad un ruolo di attesa e preparazione (ammesso che abbiano la forza di farlo) della successiva sfida congressuale. Il PD e la sua maggioranza diventano politicamente, e soprattutto in termini di potere decisionale e di partecipazione alla costruzione della linea politica, coestensivi, sono la stessa cosa, occupano in maniera esclusiva il medesimo spazio politico.
Con il conseguente bisogno, al fine di garantire compattezza e solidità, di una forte dose di ortodossia nella maggioranza, di una fiducia ed un sostegno verso il leader che non ammettano eccezioni, perlomeno palesi, nonché di un’adesione incondizionata alla sua azione e alla linea della maggioranza.
Ma se il PD prima si immedesima nei suoi Sindaci e poi nella sua maggioranza e nel suo leader, ecco che la presenza di Sindaci PD che della maggioranza non fanno parte, o che comunque per qualche motivo non sono, o non sono più, organici ad essa, diventa una criticità strutturale, un’anomalia da risolvere.
Quei Sindaci che non risultano sufficientemente integrati nell’amalgama di maggioranza diventano un corpo estraneo, un ostacolo sia per quei processi decisionali che poi a livello territoriale devono trovare la loro declinazione, sia una sorta di disturbo di frequenza nella comunicazione della linea dominante.
Osteggiati, o nel migliore dei casi tollerati, ma comunque tendenzialmente delegittimati perché rappresentanti quel pezzettino mancante di circonferenza che impedisce al cerchio di chiudersi definitivamente.
 Così si spiega il fatto che se nel Comune di Sesto Fiorentino otto consiglieri comunali del PD presentano e votano una mozione di sfiducia contro il Sindaco renzianissimo Sara Biagiotti, vengono cacciati in massa dal partito. Un’intera classe dirigente locale, legittimata da voto dei cittadini pochi mesi prima, spazzata via per decisione, presa a maggioranza, dell’organo di garanzia (sic) del partito.
Così si spiega il fatto che se nel Comune di Sesto Fiorentino otto consiglieri comunali del PD presentano e votano una mozione di sfiducia contro il Sindaco renzianissimo Sara Biagiotti, vengono cacciati in massa dal partito. Un’intera classe dirigente locale, legittimata da voto dei cittadini pochi mesi prima, spazzata via per decisione, presa a maggioranza, dell’organo di garanzia (sic) del partito.
Mentre se a Roma, (ma non solo eh, vedi anche un Comune di 37.000 abitanti come Fermo) i consiglieri renziani, senza nemmeno presentare alcuna mozione di sfiducia, vanno di fronte ad un notaio insieme alle opposizioni consiliari per firmare le loro dimissioni contestuali e far cadere il sindaco non organico, non più gradito, il tutto viene fatto rientrare in un difficile, ma inevitabile, percorso di superamento di un Sindaco “senza più la fiducia della città”.
Ma in realtà ricorda più ciò che un tempo si sarebbe chiamato normalizzazione.
O più dozzinalmente una specie di Pac Man della politica italiana, dove se all’inizio del gioco i Sindaci fantasmini rincorrevano la grande bocca del partito per mangiarsela, quando poi la grande bocca ha assunto “Renzi pillola magica” il gioco ha mutato in maniera speculare i ruoli, e la grande bocca ha cambiato d’improvviso il verso della sua corsa rimangiandosi i Sindaci.
Non stupisce dunque come Renzi si spinga ad affermare, rispetto al caso Marino, che «se la maggioranza dei tuoi consiglieri ti manda a casa, non si chiama congiura: è la democrazia, bellezza», tralasciando poi però di spiegare perché invece a Sesto Fiorentino lo stesso processo “democratico” abbia determinato la cacciata con ignominia dei consiglieri democratici protagonisti.
Ma appunto non è un banale “due pesi e due misure” a seconda della convenienza del momento, bensì l’inevitabile approdo dell’affermarsi di un soggetto politico che è contemporaneamente partito degli eletti e del leader, e dunque del venire meno della distinzione tra sfera politica e sfera istituzionale, e della contestuale riconduzione del pluralismo interno a periodica contesa per la leadership.
Con la duplice conseguenza che lo svolgimento dei ruoli istituzionali venga sempre più spesso distorta da toni e modalità proprie della dimensione di partito, e che la contesa intrapartitica irrompa nelle istituzioni, imponendo processi che non dovrebbero appartenere alla rappresentanza istituzionale, in quanto mortificanti la legittimazione democratica proveniente dal voto popolare sacrificata sull’altare di una competizione tutta interna ad un partito.
E noi democratici federalisti che quasi quasi volevamo abolire i prefetti.
Sai quanti ne serviranno?!