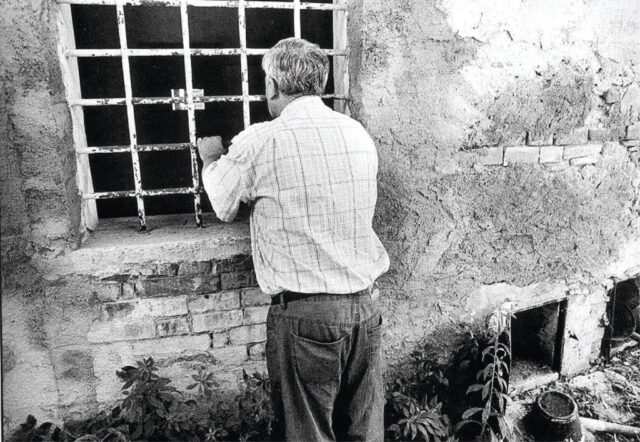Il primo matto che quasi tutti noi abbiamo incontrato tra le pagine di un libro è stato quell’Orlando non a caso definito furioso. Lui impazzisce per amore quando gli appare evidente che la “sua” Angelica non era per niente sua ma di Medoro. Esce dunque di senno, vaga seminudo nel bosco pronunciando parole prive di senso, usa uomini come bastoni per colpirne altri, distrugge tutto ciò che trova sul suo cammino. Il poema ariostesco fu ritenuto per molto tempo opera d’evasione finché Hagel non fece notare che vi era contenuta, invece, una sottile critica ai valori della cavalleria e quindi la consapevole analisi che un’epoca era finita. Così il furioso (e per noi divertente) Orlando, fornisce a suo modo una lettura della realtà e introduce l’idea che il comportamento dei matti possa anche rappresentare un giudizio, interrogare su quale sia la visione “giusta” del mondo.
La drammatizzazione della follia prodotta dalla letteratura ha indubbiamente contribuito a insinuare proprio questo dubbio sul ciò che sia “normale” (nel vivere sociale e nei comportamenti degli individui che alla società debbono conformarsi); nonché a cogliere le diverse, drammatiche (talvolta buffe) contraddizioni della natura umana. Verrebbe da citare, al proposito, la tragedia shakespeariana di Re Lear, tanto ricca di risvolti psicologici e ideologici, dove il fatto centrale è la pazzia del Re che va a coincidere con il tempestoso sconvolgimento della natura. Perché è un uragano anche quello che devasta la mente e i sentimenti dei protagonisti, fino a stravolgere, oltre la sfera privata, le gerarchie sociali. Ma attraverso il disordine della pazzia, Lear ritroverà la radice della natura umana. E questo grazie alla figura del Matto che permette al sovrano di comprendere i propri errori e le incapacità di giudizio, gli apre gli occhi.
Se poi intendiamo confrontarci con la pazzia “che ride” sarà inevitabile non pensare al Don Quijote di Cervantes: talmente divertente è il susseguirsi delle circostanze che vorremmo assumere quella pazzia a normalità. Disposti, dunque, ad essere noi gli ammirati scudieri di un animo così grande e sublime. Di follia in follia (di libro in libro) arrivare magari all’Enrico IV di Pirandello, per apprendere come “tutti siano pazzi e che la pazzia sia una scelta quasi obbligata dalla necessità di avere un posto in un mondo che non è fatto per noi”. Enrico IV è talmente convinto di tale verità che svelerà ai suoi servitori di aver finto di essere ancora pazzo perché, rinsavito, aveva scoperto amaramente di essere arrivato “con una fame da lupo ad un banchetto già bell’e sparecchiato”, riferendosi a quei dodici anni mai esistiti per lui e goduti dagli altri. La decisione, dunque, di ritornare nel limbo-prigione della pazzia è dettata dalla constatazione che nel mondo non c’è più posto per lui. Ecco, allora, il dramma dell’emarginazione umana.
Infine vorremmo, in queste sparse (e per essere in tema, un po’ schizofreniche) note, ricordare un autore, Mario Tobino (quest’anno ricorre il centenario della nascita) che da psichiatra e scrittore ha dedicato agli enigmi e ai deliri della follia emozionanti pagine. La sua concezione poetica (estetica) della pazzia e dei manicomi fu motivo di forti critiche. Non era certo in discussione la sua buona fede. Basti leggere le parole che pose in premessa ad una riedizione delle Libere donne di Magliano: “Scrissi questo libro per dimostrare che i matti sono nature degne d’amore…”. Da Tobino si ricava quindi una lezione che va oltre la letteratura: nei matti, dietro il sigillo delle loro fragilità e delle dolorose angosce, c’è comunque un termine di confronto che, in quanto paradossale, misura in noi la capacità di capire (di amare) la realtà, ovvero a quale livello di pazzia sia giunta la nostra normalità.
Tempo lettura: 3 minuti