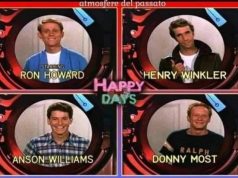Non possiamo più permetterci ottomila comuni!
Non possiamo più permetterci ottomila comuni!
Questo il tormentone del nuovo riformismo aziendalista efficientista ammazza-municipi. Nuova versione di quello ammazza-province, salvo poi piangere sul latte versato e riempire di lacrime le buche sulle strade.
Ma di preciso cosa significa? Da quando non possiamo più permetterceli? Perché? In che senso non possiamo farlo? Settemilanovecentocinquanta invece vanno bene?
Soprassediamo sul fatto che i tedeschi evidentemente possono permettersene undicimila di analoghe dimensioni medie e i francesi trentaseimila di dimensioni molto più piccole. Ma loro mica sono attenti ai conti pubblici come lo siamo noi.
Passiamo anche sopra al fatto che “ce li siamo permessi” ‘sti benedetti comuni in periodi della storia italiana ben peggiori di quelli odierni.
 Facciamo anche finta di non conoscere le spese del Parlamento, dei ministeri, delle regioni, gli stipendi a sei cifre di quegli stessi parlamentari e consiglieri regionali che tanto si preoccupano di quelle a quattro dei sindaci, e di quelle a tre o due di consiglieri e assessori nei piccoli comuni.
Facciamo anche finta di non conoscere le spese del Parlamento, dei ministeri, delle regioni, gli stipendi a sei cifre di quegli stessi parlamentari e consiglieri regionali che tanto si preoccupano di quelle a quattro dei sindaci, e di quelle a tre o due di consiglieri e assessori nei piccoli comuni.
Non andiamo nemmeno a scomodare questioni di identità storica e di tenuta sociale garantite dai piccoli comuni. Sono astrazioni quelle, roba filosofica.
Vediamo di parlare il linguaggio dei soldi che si comprende meglio.
Bene. Però allora se il piano di discussione deve essere questo, uno si ferma un attimo a pensare, e poi si domanda: se i piccoli comuni sono solo un problema di costi, perché questo vanno in giro a raccontare i politici ammazza-municipi, allora per quale motivo i “costi standard” sono stati all’improvviso rificcati dentro un cassetto?
Cosa sono i costi standard? Eh già, pochi lo sanno, perché fa più comodo raccontare altro. Molto più agevole dare in pasto il capro espiatorio dei piccoli comuni ad un’opinione pubblica incavolata nera per gli anni di ruberie e di inadeguatezza della politica nazionale, che approfondire il dibattito sui numeri. Molto meglio sventolare sotto il naso degli italiani i presunti risparmi che si otterrebbero in periferia cancellando comuni, così da nascondere l’incapacità di attaccare le inefficienza degli apparati centrali.
 I costi standard sono dei livelli di costo che lo Stato si era impegnato a fissare per ogni servizio comunale, uno ad uno, attraverso un’ampia statistica condotta su tutto il territorio nazionale. Ai tempi di quando eravamo tutti federalisti. Ai tempi in cui si diceva che “le istituzioni devono stare vicino al controllo dei cittadini”, del “diamo autonomia e responsabilità agli enti locali e ai territori”.
I costi standard sono dei livelli di costo che lo Stato si era impegnato a fissare per ogni servizio comunale, uno ad uno, attraverso un’ampia statistica condotta su tutto il territorio nazionale. Ai tempi di quando eravamo tutti federalisti. Ai tempi in cui si diceva che “le istituzioni devono stare vicino al controllo dei cittadini”, del “diamo autonomia e responsabilità agli enti locali e ai territori”.
Insomma prima che il Governo Monti e le tecnocrazie italiane ed europee imponessero il “contrordine sudditi” e tutti i governi successivi si adeguassero proni.
Si era cominciato a reperire dati in tutta Italia proprio allo scopo di riorganizzare la spesa dei comuni, fissando per tutte le Amministrazioni delle soglie di virtuosità.
Niente di più banale come meccanismo.
Si fa il calcolo del costo standard prendendolo dai comuni che spendono meno nella penisola, lo si proporziona al numero di abitanti, lo si ricalibra un po’ in base al luogo dove si trova il comune (perchè una cosa, si converrà, è erogare i servizi in una ricca area del nord, altro farlo in una povera del sud), si dà una mano ai comuni delle zone disagiate perché mi pare un principio di solidarietà persino ovvio, e poi si impone ad ogni singolo comune di non superare quei limiti.
 Caro Comune il tuo ufficio segreteria deve costare x, il tuo ufficio contabile y, la tua polizia municipale z e così via fino all’ultima spesa.
Caro Comune il tuo ufficio segreteria deve costare x, il tuo ufficio contabile y, la tua polizia municipale z e così via fino all’ultima spesa.
Se quel Comune non ce la fa a mantenersi sui livelli di spesa prestabiliti incrementa l’accorpamento intercomunale degli uffici, si colloca dentro un’Unione, si inventa soluzioni organizzative nuove, rivede le tipologie dei servizi; fa quello che ritiene più utile allo scopo. Toglie le indennità agli Amministratori, mette il sindaco a spazzare le strade, fissa una quota da pagare per partecipare ai consigli comunali come rimborso del costo della luce.
Cerca insomma tutte le soluzioni per mantenersi all’interno dei limiti che la comunità nazionale gli impone, ma lo fa nel pieno della sua autonomia, e soprattutto nella prospettiva di continuare ad esistere.
Se poi quel Comune non trova soluzioni adeguate lo si commissaria per inefficienza, lo si espone al pubblico ludibrio e lo si riporta d’imperio nei limiti fissati dai costi standard.
Crudele e senza pietà no? Sufficientemente tranchant per soddisfare la fame degli ammazza-comuni. Ma almeno il problema dei costi è risolto e quello delle dimensioni dei comuni lo stesso. Piccoli, grandi, medi, piccolissimi, metropoli. Un volta stabilita quale è la soglia di spesa che… possiamo permetterci, la dimensione non conta più; l’importante è che in proporzione al numero di abitanti quel Comune spenda la somma che riteniamo congrua.
E lo sapete? Non ve lo raccontano mai, ma i piccoli comuni non avrebbero proprio nulla da obiettare. Come si dice oggi? Accetterebbero la sfida, ci metterebbero la faccia! Perché sono anni che accettano la sfida della razionalizzazione lavorando a testa bassa sui costi, sempre più ridotti alla fame da uno Stato che invece continua a far lievitare il suo debito pubblico. I piccoli comuni vogliono continuare ad esistere e difendono la loro autonomia, ma non lo fanno nella conservazione, non temono di giocare la partita dell’innovazione.
Invece i costi standard sono spariti dal dibattito, non vanno più di moda e si tirano fuori al loro posto studi, ricerche, grafici commissionati ad hoc per dimostrare che dalle fusioni dei comuni passa il futuro della nostra nazione.
Ancora non si è fatto in tempo a verificare gli effetti dell’obbligatorietà dell’associazione dei servizi (anche perché si continuano a dare proroghe su proroghe), ma già l’accorpamento degli uffici è diventata roba obsoleta, superata, da conservatori.
Per traghettare l’Italia nel futuro meglio presentare leggi per cancellare i comuni sotto i cinquemila abitanti, dare soldi per qualche anno come specchietti per le allodole ai comuni che si fondono, promettere di assegnare punteggi privilegiati nei finanziamenti regionali ai comuni fusi, smentire nei consigli regionali la contrarietà alle fusioni espressa dalle comunità con referendum popolari, fare ogni forzatura possibile, e anche quelle impossibili. Insomma meglio renderle obbligatorie di fatto o per legge le fusioni.
Perché non dimentichiamoci che in realtà fondere i comuni è stato sempre stato possibile nell’Italia repubblicana. Le fusioni sono previste dalla Carta costituzionale, e giustamente le comunità che ritenevano di dover procedere, esprimendosi inequivocabilmente in tal senso, lo hanno liberamente fatto ed è giusto che siano libere di farlo ancora.
La novità odierna sta nell’obbligatorietà che si vuole imporre per legge, ma soprattutto nell’obbligatorietà di fatto che Stato e Regioni, con la complicità attiva dei partiti, stanno gradualmente costruendo.
Quella a cui assistiamo è una vera e propria aggressione ai piccoli comuni, nei toni politici e nella sostanza giuridica e amministrativa.
Perché in realtà non è un problema di costi. Ma a chi la vogliono raccontare costoro! Altro che costi standard!
L’obiettivo vero sta nel modello di governo che si vuole imporre al Paese.
Tranquilli, nessuna complicata interpretazione politologica o sociologica, lo diciamo in maniera semplice: più allontani la politica e le istituzioni dai cittadini, e più chi detiene il potere se lo gestisce come meglio crede.
E oggi chi ha in mano il potere vuole esercitarlo subendo il minor controllo democratico possibile, e approfittando per spostare risorse, in tempi di vacche magre, dalle zone rurali, montane e periferiche verso quelle centrali e metropolitane.
Un’operazione su larga scala di fusioni di comuni è perfettamente funzionale a questo obiettivo.