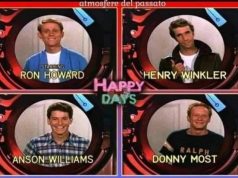Ci sono studi che giungono alla conclusione che i migliori comuni sarebbero quelli compresi tra i 10 ed i 20 mila abitanti, e che dunque andrebbero fusi tra loro quelli che ne hanno meno. Sul perché poi, conseguentemente, non vadano scissi, fino al raggiungimento della soglia ottimale, quelli che ne hanno di più, si attendono invece analisi integrative.
Tali studi, branditi ad ogni pie’ sospinto dai sostenitori delle fusioni, si basano sul parametro della spesa pro-capite: tanto minore è la spesa annuale sostenuta dal comune per ogni cittadino, e tanto più il comune sarebbe virtuoso.
Insomma tipo una fabbrica di bulloni: più basso è il costo di produzione per bullone e più sei concorrenziale sul mercato. E sottolineo bulloni, nemmeno chennesò, biscotti, perché i biscotti non sono tutti uguali, ce ne sono di più buoni e di più cattivi, e dunque oltre al costo di produzione entra il gioco anche la qualità del prodotto.
 Ora si dà il caso – se proprio non ce la si fa a considerare l’amministrazione pubblica qualcosa di diverso da una catena di montaggio – che i servizi prodotti dai comuni somigliano semmai molto più a biscotti che a bulloni, perché i servizi possono essere buoni, e si rende la vita dei cittadini migliore, oppure cattivi, e si manca l’obiettivo.
Ora si dà il caso – se proprio non ce la si fa a considerare l’amministrazione pubblica qualcosa di diverso da una catena di montaggio – che i servizi prodotti dai comuni somigliano semmai molto più a biscotti che a bulloni, perché i servizi possono essere buoni, e si rende la vita dei cittadini migliore, oppure cattivi, e si manca l’obiettivo.
Dunque al parametro della spesa pro-capite intanto andrebbe aggiunto quello della soddisfazione del cittadino, e coloro che parlano dei piccoli comuni come di un retaggio medievale, dovrebbero intanto andare a chiedere a quei cittadini se vivono bene o male. Chiederlo persino a quelli dei “micro-comuni” alpini da cento abitanti, tanto derisi nei servizi dei telegiornali perché magari il Sindaco fa lo spazino. Quello che conta è se quei cittadini sono soddisfatti, è la qualità della loro vita che fa la differenza tra un comune virtuoso ed uno che non lo è, non certo una statistica finanziaria fine a se stessa.
Ma sono spese che non possiamo più permetterci, viene detto.
Ma “permetterci” chi? Cioè, chi mantiene chi? I Comuni da un po’ di tempo a questa parte sono autonomi finanziariamente, più o meno spendono quello che deriva loro dalla tassazione locale, anzi in parte fungono da esattori per conto dello Stato, riscuotendo denaro che poi trasferiscono al centro.
Chiedono risorse ai loro cittadini e quelle spendono.
Non sono nel libro spesa dello Stato, se non in misura infinitesimale rispetto al resto dell’apparato pubblico (semmai sul groppone di tutti ci sono i “bilanci cattivi” dei grandi comuni in dissesto).
 Dunque è alle comunità locali che andrebbe chiesto se il rapporto tra livello di tassazione e servizi comunali erogati è per esse soddisfacente, e magari porre la domanda in termini relativi rispetto ai servizi erogati dalle Regioni e dallo Stato, tanto per vedere un po’ l’effetto che fa.
Dunque è alle comunità locali che andrebbe chiesto se il rapporto tra livello di tassazione e servizi comunali erogati è per esse soddisfacente, e magari porre la domanda in termini relativi rispetto ai servizi erogati dalle Regioni e dallo Stato, tanto per vedere un po’ l’effetto che fa.
Ci sarebbe poi bisogno di fare un ulteriore sforzo, e provare a ragionare sul fatto che i comuni più piccoli sono spesso quelli rurali e montani, i quali hanno mediamente una bassa densità di popolazione.
Di qui fare un ulteriore passo e cogliere il dato che dove la densità di popolazione è bassa e i cittadini vivono sparsi sul territorio, erogare un servizio costa necessariamente di più in termini unitari per cittadino. Un esempio banale: per riempire uno scuolabus in una zona densamente abitata ci metto dieci minuti, per riempirlo in mezzo ai monti e alla campagna ci metto due ore. Ovvio che nel secondo caso il costo pro-capite del servizio risulterà in ogni caso più alto.
Potrebbe così maturare il dubbio che il dato della spesa pro-capite dipenda anche dalla densità di popolazione, chissà forse ancor più che dal numero di abitanti. Ma la densità di popolazione è un dato non modificabile dalle fusioni, visto che la distribuzione dei cittadini sul territorio non cambia fondendo i comuni, perché tutti rimangono ad abitare dove abitavano prima, a meno che non si pensi di organizzare deportazioni di massa verso i nuovi capoluoghi.
In fondo si avverte anche a naso come risulti piuttosto bizzarro costruire teorie efficientiste sul solo numero di abitanti, come se fosse l’unico elemento costitutivo di un comune, e non tenere anche nella dovuta considerazione la sua estensione territoriale.
Che poi, a pensarci bene, ma il fatto che dietro a certi innamoramenti per le fusioni ci sia, più o meno consapevolmente, l’idea che sia un bene che i cittadini montani scendano a valle e che quelli di campagna vadano in città così da ridurre la spesa pubblica, non è proprio una deduzione cosi peregrina. O comunque questo è l’effetto che le fusioni, allontanando sempre più i servizi dalle zone periferiche, rischiano di produrre, cioè lo spopolamento delle aree rurali e montane, il che sarebbe una vera e propria catastrofe sociale ed economica.
Per non parlare poi del fatto che le statistiche non andrebbero fatte mischiando le pere con le mele, perché non è affatto detto che un comune, consolidatosi storicamente nella sua conformazione geografica, sociale, economica ed identitaria, sia equiparabile, in termini di efficienza amministrativa, per il solo fatto di avere un numero di abitanti analogo, ad uno nato da una fusione decisa a tavolino. Basti pensare, una fra tutte, alle possibili conseguenze in termini sociali e di rappresentanza politica che possono sorgere nei rapporti tra le popolazioni dei due ex comuni.
Insomma, come dicevamo all’inizio, ci sono studi…. ma ce ne vorrebbero altri, e magari commissionati con l’obiettivo di comprendere la realtà e non di dimostrare una tesi precostituita. Perché che si giochi con i numeri, e con gli assi cartesiani, per dimostrare ciò che si vuole è una sensazione difficile da togliersi di dosso.
A volte si gioca un po’ anche con i soldi pubblici.
Viene infatti da chiedersi: ma se fondere due comuni rende quello risultante così efficiente in termini finanziari, perché Stato e Regioni sentono il bisogno di trasferire per anni denaro, i cosiddetti incentivi, a chi decide di fondersi aumentando la spesa pro-capite complessiva? Oh non s’era detto che si faceva per risparmiare?