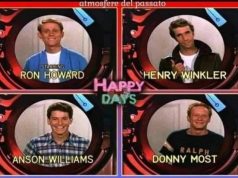C’è chi lo ha chiamato, come ad esempio Samuel P. Huntington, «sovraccarico istituzionale», o anche «sovraccarico del processo decisionale»
C’è chi lo ha chiamato, come ad esempio Samuel P. Huntington, «sovraccarico istituzionale», o anche «sovraccarico del processo decisionale»
Circa un secolo e mezzo prima Alexis de Tocqueville, nel suo “La democrazia in America”, la chiamava “rivoluzione irresistibile”.
In soldoni è quella teoria secondo la quale le democrazie hanno la naturale tendenza ad accrescere nel tempo il loro grado di democraticità, e gli spazi in cui esso si manifesta. Insomma tenderebbero a diventare sempre più partecipate dai cittadini, che maturerebbero progressivamente consapevolezza e avanzerebbero ai governi sempre più pretese.
Solo che mentre Tocqueville rimase ammirato dal vedere ciò accadere in America, dal vedere crescere la democrazia in un inarrestabile percorso pacifico verso l’eguaglianza, Huntington, insieme ad altri importanti studiosi, ne fece nel 1975 una preoccupata, e rimasta famosa, relazione alla Commissione Trilaterale (il gruppo di studio internazionale fondato nel 1973 da David Rockfeller) che si tenne in quell’anno a Kyoto. Relazione che a rileggerla oggi sembra il presupposto di ciò che accade in Italia da qualche anno a questa parte.
Ciò che accade dal giorno in cui nacquero le “larghe intese” e salì al potere uno come Mario Monti che di organismi come la Commissione Trilaterale o il Gruppo Bilderberg è un fan sfegatato, con a casa tutta la relativa collezione di merchandising: magliette, pantaloncini e cappellini da indossare nei mesi estivi.
Infatti secondo quella famosa relazione collettiva alla Trilaterale il “sovraccarico istituzionale”, cioè l’eccesso di partecipazione al processo decisionale, la presenza di troppe istanze che provengono dal basso, il troppo occuparsi consapevolmente da parte dei cittadini della cosa pubblica, in definitiva il sovraccarico di democrazia, rappresentano un grave problema strutturale che può condurre, in una sorta di corto circuito, prima ad una crisi e poi ad una trasformazione del sistema, ad un suo cambio netto di paradigma. Per chi in quel sistema ha ben radicati i propri interessi economici, il proprio potere, la propria rete di rapporti di dominio e la propria collocazione in quelle elites che decidono e determinano, le trasformazioni radicali rischiano di essere la fine dei giochi, la loro fine come attori sociali privilegiati. Dunque nasce il bisogno di difendersi, di reagire, di prendere contromisure per autoconservarsi. Guarda un po’, tra le soluzioni proposte dai relatori per evitare il sovraccarico e la trasformazione del sistema compariva una limitazione delle sfere in cui si applicano i procedimenti democratici, insieme al provocare una dose di apatia e disimpegno in precisi individui e gruppi. Insomma riduzione degli spazi democratici e disinteresse indotto alla politica, in funzione di una normalizzazione delle spinte sociali centifrughe.
 Certo, riflessioni di quaranta anni fa, ma qui non si vuole dimostrare ovviamente una relazione di diretta causalità con i fatti italiani odierni, ma solo osservare che le cose non avvengono mai a caso. Le decisioni politiche a certi livelli hanno sempre un’origine più complessa e meno immediata di quanto appaia, e spesso sono riconducibili, in termini causali, a processi molto più organici, consapevoli e strutturati di quanto si pensi. Poi quali tra i singoli politici, ai vari livelli, siano decisori consapevoli o inconsapevoli esecutori di un disegno più grande di loro, è un altro discorso.
Certo, riflessioni di quaranta anni fa, ma qui non si vuole dimostrare ovviamente una relazione di diretta causalità con i fatti italiani odierni, ma solo osservare che le cose non avvengono mai a caso. Le decisioni politiche a certi livelli hanno sempre un’origine più complessa e meno immediata di quanto appaia, e spesso sono riconducibili, in termini causali, a processi molto più organici, consapevoli e strutturati di quanto si pensi. Poi quali tra i singoli politici, ai vari livelli, siano decisori consapevoli o inconsapevoli esecutori di un disegno più grande di loro, è un altro discorso.
Altro però che Italia semplice!
Solo partendo da questo presupposto riesci ad incasellare fenomeni apparentemente inspiegabili, come l’improvviso salto da un’Italia federalista (eravamo tutti federalisti) ad una centralista, in coincidenza con l’avvento dei governi delle larghe intese; come l’accanimento che di lì in poi è cominciato a danno delle autonomie locali, o come l’apparente indifferenza verso percentuali di astensione elettorale (vedi “apatia e disimpegno” di cui sopra) a livelli record.D’altronde cosa di più “normalizzante” ci può essere di governi ai quali partecipano, ad assetti variabili, pressoché tutte le principali forze politiche, come nelle larghe intese? La centralizzazione dei servizi pubblici essenziali, con il loro allontanamento dal controllo delle istituzioni locali e dei cittadini; il possibile accorpamento delle regioni, l’abolizione delle province, la riduzione del numero dei componenti i consigli comunali, e oggi la paventata fusione dei comuni sono tutte “limitazioni delle sfere in cui si applicano i procedimenti democratici”. Sono spazi democratici che vengono meno dentro un processo che sposta i momenti decisionali dal basso, dai territori, verso l’alto, verso il governo centrale, e che riduce il livello di partecipazione politica complessiva.
La centralizzazione dei servizi pubblici essenziali, con il loro allontanamento dal controllo delle istituzioni locali e dei cittadini; il possibile accorpamento delle regioni, l’abolizione delle province, la riduzione del numero dei componenti i consigli comunali, e oggi la paventata fusione dei comuni sono tutte “limitazioni delle sfere in cui si applicano i procedimenti democratici”. Sono spazi democratici che vengono meno dentro un processo che sposta i momenti decisionali dal basso, dai territori, verso l’alto, verso il governo centrale, e che riduce il livello di partecipazione politica complessiva.
Un trasferimento di potere dal basso verso l’alto che, in epoca di tangenti e malaffare nel Paese dell’eterna tangentopoli, trova nell’antipolitica, nella reazione rabbiosa contro i politici che si estende alla politica in quanto tale, il suo poderoso vettore. Quale momento migliore di oggi per sfruttare, a colpi di demagogia, i movimenti di pancia dei cittadini, schifati dagli scandali giornalieri, cogliendo l’occasione per fare di tutta l’erba un fascio?
Cosicché tutte le misure di attacco alle autonomie locali, tese a rendere sempre più asfittica l’arena democratica, finiscono dalla tecnica legislativa per essere inserite sotto la voce “costi della politica” (se avete pazienza di andare a leggervi i relativi testi di legge ne troverete conferma), come se le spese per il funzionamento della democrazia fossero sempre e comunque sprechi, soldi buttati via per mantenere politici ladri e fannulloni.
Così Renzi il giorno dell’approvazione della legge Delrio sul riordino delle province può twittare, in brodo di giuggiole, che sono state eliminate tot indennità e tot poltrone. Poi se il sistema migliora o peggiora è fatto secondario.
Allo stesso modo in cui occupandosi degli accorpamenti dei comuni i mass media ne elogiano i benefici attraverso la quantificazione del numero di politici che vengono fatti fuori nei territori.
Coerente con tutto quanto detto fin qui è l’odierna esaltazione mistica del PD toscano per le fusioni dei comuni. Un tam tam mediatico che, nella migliore tradizione toscana in epoca renziana (vedi Schicchera sulla legge elettorale del 21/04/2014), mira a preparare il terreno, in una sorta di laboratorio locale, per poi compiere la stessa operazione a livello nazionale, in questo caso appunto introdurre l’obbligatorietà per legge nazionale della fusione dei piccoli comuni.
 Vengono ricacciati fuori vecchi studi dell’Irpet e cartine con i nuovi confini comunali tirati a tavolino, come le forze coloniali tirarono quelli dell’Africa, solo che in questo caso sembrano fatti a vegliatura al bar, con pezzi di Toscana che vanno e vengono nelle e dalle regioni limitrofe.
Vengono ricacciati fuori vecchi studi dell’Irpet e cartine con i nuovi confini comunali tirati a tavolino, come le forze coloniali tirarono quelli dell’Africa, solo che in questo caso sembrano fatti a vegliatura al bar, con pezzi di Toscana che vanno e vengono nelle e dalle regioni limitrofe.
Non sono più tollerabili 8000 comuni in Italia!
Prova a dire loro che in Francia, nazione dalla quale importiamo storicamente buoni modelli amministrativi e dalla tradizione centralista, ce ne sono ben 36.000 e nessuno si sogna di cancellarne, anzi i francesi vanno orgogliosissimi delle loro istituzioni locali.
Bisogna ridurre i costi!
Inutile far notare quanta parte infinitesimale della spesa pubblica italiana sia imputabile ai piccoli comuni.
Occorre razionalizzare e rendere efficienti i piccoli comuni!
Tempo perso far notare loro che ciò che costa davvero sono i servizi, non gli organi istituzionali. E che per razionalizzare occorre accorpare quelli, organizzarli in forma associata (appunto come accade in Francia) nelle Unioni o attraverso convenzioni, senza alcun bisogno di cancellare comuni e ridurre la partecipazione democratica nei territori.
Loro continuano nel fare volutamente confusione tra gestione e indirizzo politico, due dimensioni nettamente separate oggi dentro le Amministrazioni comunali. Una confusione che serve a nascondere il fatto che tutti gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione che si propongono possono essere raggiunti accorpando le gestioni, gli uffici, senza la necessità di fondere i comuni e cancellare sindaci e consigli comunali.
Ma spesso si va anche oltre il fumo negli occhi, arrivando ad adottare veri e propri sabotaggi, come la riduzione delle indennità dei sindaci di comuni fino a 3000 abitanti sotto la soglia di uno stipendio minimo, così da rendere difficile persino trovare chi può permettersi di svolgere quel ruolo in quelle comunità. Oppure come le ultime norme sulle unioni dei comuni introdotte dalla Regione Toscana, in un blitz a due mesi dalla ultime elezioni, che rendono la vita delle stesse molto più complicata, mentre le fusioni si incentivano a colpi di migliaia di euro e i chi si fonde viene premiato con tanto di targa alla gloria imperitura consegnata in Consiglio Regionale.
Poi nemmeno è il caso di cimentarsi nell’impresa di spiegare che le istituzioni non sono fabbriche di bulloni (con tutto il rispetto per i bulloni), in cui il risultato finale si misura solo in termini di costi e profitti. D’altronde da due decenni l’efficientismo e l’aziendalismo applicato alla cosa pubblica sono la cifra che caratterizza la classe politica di governo, in un’imbarazzante continuità e contiguità tra parti politiche diverse.
Per chi abita in provincia i piccoli comuni sono invece anche storia, identità, immedesimazione collettiva, socializzazione, i luoghi dell’essere cittadini e comunità.
Le municipalità sono la migliore tradizione civica che abbia attraversato la nostra storia moderna e contemporanea.
Con tutti i loro difetti certo, ma in questi ultimi venti anni i piccoli comuni sono stati ciò che ha retto nel Sistema Italia, sono stati un baluardo di democrazia e di tenuta istituzionale in una nazione immiserita dal malcostume, in un sistema partitico lordato dal malaffare e in uno Stato sventrato dagli scandali.
Ma non c’è ragionamento razionale che tenga dentro una rappresentazione di comodo in cui tutto ciò che non è mainstream, pensiero politico dominante, è tacciato di localismo, campanilismo, provincialismo.
Una rappresentazione che ci racconta come in un’Italia che deve confrontarsi con la feroce competizione del mondo globalizzato e operare con efficacia sullo scenario internazionale, non c’è lo spazio per perdere tempo con tutti questi rappresentanti dei cittadini, con tutti questi politici sparsi sui territori, che rompono solo le scatole e non comprendono i veri interessi della nazione. Più se ne fanno fuori e più si tengono i cittadini lontani dai luoghi in cui si decide, più veloce la Nave Italia può solcare i mari della modernizzazione.
Scriveva Tocqueville: «Cʼè forse qualcuno che può pensare che la democrazia, dopo aver distrutto il feudalesimo e aver vinto i Re, indietreggerà poi davanti ai borghesi e ai ricchi?»
Chissà magari questa è la #voltabuona no?