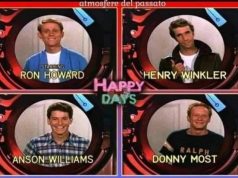Il male di vivere. Cominciò a evocarlo Chateaubriand parlando di mal du siècle, poi fu la volta dello spleen baudelairiano (“Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve / schiaccia l’anima che geme nel suo eterno tedio, e stringendo in un unico cerchio l’orizzonte / fa del dì una tristezza più nera della notte…”. Infine giunse Montale, con quei versi che dettero un (non)senso alle nostre paturnie: “Spesso il male di vivere ho incontrato: / era il rivo strozzato che gorgoglia, / era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato”.
Il male di vivere. Cominciò a evocarlo Chateaubriand parlando di mal du siècle, poi fu la volta dello spleen baudelairiano (“Quando, come un coperchio, il cielo pesa greve / schiaccia l’anima che geme nel suo eterno tedio, e stringendo in un unico cerchio l’orizzonte / fa del dì una tristezza più nera della notte…”. Infine giunse Montale, con quei versi che dettero un (non)senso alle nostre paturnie: “Spesso il male di vivere ho incontrato: / era il rivo strozzato che gorgoglia, / era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato”.
E giusto il male di vivere – ormai lo scrivono pedissequamente anche gli odierni diciottenni agli esami di maturità – ha ammorbato l’intero Novecento. Secolo breve, ma alacre nel distruggere le apparenti certezze e gli assetti sociali che su certe convinzioni (e convenzioni) poggiavano. Così che pure i fortunati che si erano risparmiati la sciagura di due guerre e che godevano gli agi borghesi della rinascita non furono affatto immuni dallo spleen. Anche perché il “male di vivere” è altra cosa dal “problema di vivere”, ovvero dalla sussistenza. A volerla dir tutta, è a suo modo un lusso. Furono, dunque, fortunati coloro che poterono porsi la questione della insensatezza e della futilità della vita, per stabilire, sempre con Montale, che le uniche certezze erano “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. O cercarono con il “non domato spirito” di Saba il senso profondo dell’essere, scoprendo quanto il belato di una capra fosse “fraterno al mio dolore”. E ancora inseguirono consonanze con l’ungarettiana “allegria” e quella “solitudine in giro / titubante ombra dei fili tranviari / sull’umido asfalto”.
Negli ultimi decenni in cui il Novecento accelerò il proprio liquefarsi non mancarono espressioni artistiche più alla buona (ma non meno oscure e malinconiche) come quelle musicali della new (darke) wave. Allorquando persino le chitarre elettriche fecero propria la fierezza cosmico-negativa che già era stata di Leopardi.
E al tempo di Internet che fine ha fatto il male di vivere? Forse debellato dal fatuo egotismo che alimenta il web? Può darsi. Fin tanto non torni a chiamarsi rete la trappola di fili e salmastro che il poeta degli Ossi di seppia guardava invocando: “Cerca una maglia rotta nella rete / che ci stringe, tu balza fuori, fuggi! / Va, per te l’ho pregato, – ora la sete / mi sarà lieve, meno acre la ruggine”.
Nel clima culturale dei nostri giorni, ove nulla ci si domanda perché esauriti paiono i dubbi, un sano (sia perdonato l’ossimoro) male di vivere apparirebbe provvidenziale. Se non altro per verificare se siamo tutt’ora vivi.
Tempo lettura: 2 minuti