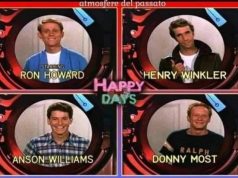Nel Talmud Babilonese, redatto intorno al quarto secolo dopo Cristo, si raccomanda di dividere la propria ricchezza in tre parti: un terzo nella terra, un terzo in mercanzia e un terzo in contanti (Bavà Metzià, capitolo 42a). Oggi chiameremmo questi tre comparti investimenti immobiliari, investimenti mobiliari e liquidità. Nei diciassette secoli successivi la teoria degli investimenti finanziari ha fatto qualche passo in avanti, ma in realtà non così stravolgenti visto che uno dei principi cardine della teoria resta la diversificazione.
Nel Talmud Babilonese, redatto intorno al quarto secolo dopo Cristo, si raccomanda di dividere la propria ricchezza in tre parti: un terzo nella terra, un terzo in mercanzia e un terzo in contanti (Bavà Metzià, capitolo 42a). Oggi chiameremmo questi tre comparti investimenti immobiliari, investimenti mobiliari e liquidità. Nei diciassette secoli successivi la teoria degli investimenti finanziari ha fatto qualche passo in avanti, ma in realtà non così stravolgenti visto che uno dei principi cardine della teoria resta la diversificazione.
Forse l’insegnamento rabbinico ha ispirato gli estensori del protocollo di intesa fra l’ACRI, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, e il Ministero dell’Economia e Finanze che dovrebbe rappresentare il nucleo dell’annunciata riforma delle fondazioni bancarie, e che prevede che le fondazioni stesse non potranno investire più di un terzo del loro patrimonio in un singolo attivo. Le fondazioni associate all’ACRI si sono impegnate ad aggiornare i loro statuti seguendo tale protocollo.
Per quanto suggestiva, l’ispirazione talmudica è improbabile. Più semplice pensare all’influenza della storia recente della Fondazione Mps, che ha dilapidato un ingentissimo capitale pubblico investendo l’intero suo patrimonio nelle azioni della banca, anzi è andata addiritttura a leva indebitandosi per aderire a vari aumenti di capitale. Un’altro pilastro del protocollo è infatti l’impegno ad evitare qualunque forma di indebitamento, «salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità». Si raccomanda altresì di non utilizzare strumenti derivati salvo che per finalità di copertura (il che però contraddice la raccomandazione di non usarli, visto che i derivati sono essenzialmente strumenti di copertura). Del resto, né i debiti né i derivati erano previsti dal Talmud.
Le raccomandazioni dell’ACRI sono del tutto condivisibili, forse talmente condivisibili da apparire superflue. Per quel che riguarda la diversificazione, un terzo appare pure troppo visto che non siamo più nel quarto secolo ma nel ventunesimo, e le possibilità di investimento si sono moltiplicate. Il fatto che le fondazioni non dovrebbero indebitarsi o utilizzare derivati a fini speculativi dovrebbe essere un principio irrinunciabile nella gestione di patrimoni pubblici, ed è un po’ sinistro che occorra metterlo per iscritto. Il protocollo prevede poi una serie di raccomandazioni di governance piuttosto blande, tipo un tetto agli stipendi (tutt’altro che ingeneroso: 240.000 euro, lo stesso emolumento del Presidente della Repubblica) e alla durata degli incarichi, una maggior rappresentanza di genere e un richiamo a maggior trasparenza e indipendenza.
Quale sarà l’impatto sulle fondazioni di questo protocollo? La risposta è: praticamente nullo. Il protocollo suona infatti più come una serie di buone intenzioni per il futuro che come un tentativo di sconvolgere il sistema vigente. Forse qualche fondazione dovrà ridefinire leggermente i propri investimenti. E’ utile sapere che non potrà ripetersi il caso di una fondazione che investe tutto il suo patrimonio in un singolo attivo, rischiando di perderlo per intero. Ma è impossibile non pensare che questa raccomandazione arrivi troppo tardi, quando ormai i danni sono irreparabili.