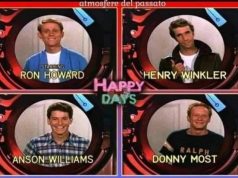Ogni volta che torno a Sabaudia – dove da sempre risiede la famiglia di mia moglie – ci sono due luoghi che non posso mai mancare di visitare. Impiego il verbo “potere” nel suo significato più stringente, che è quello di “avere la forza”, di “avere la libertà”, di “avere la facoltà”. A tal punto Sabaudia – due posti di Sabaudia in particolare – esercita su di me un’attrazione alla quale non mi è concesso di resistere. Tanto vale, perciò, che io mi consegni liberamente a essa, così come Seneca esortava Lucilio ad accettare di buon grado ciò che proviene dalla divinità, poiché, in ogni caso, Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (“Il destino conduce chi vuole lasciarsi guidare, trascina chi resiste”).
Questi due luoghi sono il centro storico e le spiagge del litorale. Il centro storico costituisce uno dei migliori esempi del razionalismo fascista, con le sue forme lineari e sobrie, con le sue strade perpendicolari e i suoi palazzi squadrati. Penso, ad esempio, alla torre civica, rivestita in travertino, all’ex Casa del Fascio (Sabaudia è una delle cinque città che furono costruite a partire dagli anni Trenta dopo la bonifica delle paludi dell’Agro Pontino), che oggi ospita la sede della Guardia di Finanza, al palazzo delle Poste, opera di Angiolo Mazzoni, con i suoi ampi finestroni incorniciati da un cordolo marmoreo, alla chiesa della S.S. Annunziata, col suo mosaico che sovrasta il portone d’ingresso. Sospesa tra atmosfere che ricordano la pittura metafisica di De Chirico e un “sottile fascino melanconico ed echeggiante” (l’espressione è di Alberto Moravia), Sabaudia, al pari di tutto ciò che rivela uno sviluppo coerente a partire da un fulcro centrale – in questo caso la torre civica, alta 42 metri – mi comunica un senso di ordine, mi dà l’illusione che anche il caos che mi abita possa un giorno essere sostituito da una stabile unità, in grado di armonizzare, senza lasciarlo esplodere, tutto ciò che in me è diversità, è molteplicità, è contraddizione.
Il secondo posto di Sabaudia che sento di amare di un amore viscerale è il lungo litorale (circa venti chilometri) che da Torre Paola raggiunge Latina. Le dune di sabbia bianca, alte fino a ventisette metri, la macchia mediterranea che le ricopre, le passerelle, tutte in legno e rigorosamente in legno, che permettono di raggiungere dalla strada la spiaggia, l’imponente sagoma del Monte Circeo, col suo profilo di donna, costituiscono un controcanto rispetto al canto rappresentato dal centro urbano. Quanto quest’ultimo, infatti, reca ovunque il segno della presenza dell’uomo, dell’homo faber che sa progettare, disciplinare, edificare, tanto il primo appare, invece, dominato dalla natura, la quale affida al vento, che spesso si leva a increspare la superficie dell’acqua marina, il compito di ricordare che essa vive di una vita propria, ora generativa ora distruttiva, ma, che in ogni caso, prescinde – può prescindere – dall’agire umano.
La commozione che suscita in me la visione del documentario, trasmesso la prima volta dalla Rai TV il 7 febbraio 1974, nel quale Pier Paolo Pasolini istituisce un confronto tra il potere fascista e il potere della civiltà dei consumi, è in larga parte legata proprio al fatto di essere stato girato a Sabaudia, dove lo scrittore bolognese e Moravia si fecero costruire “spalla a spalla”, come ha affermato il loro comune amico Enzo Siciliano, “una casa doppia”. Nel filmato Pasolini appare col volto scavato, i capelli scompigliati dal vento, il cappotto scuro aperto sul davanti che lascia intravedere il maglione a losanghe. Nei movimenti e nel gesticolare la consueta energia, la consueta forza, ma, stavolta, anche la stanchezza rassegnata, che prende chi sa – chi ha compreso – che è destino ineluttabile che il pianto accompagni sempre “ciò che muta, / anche per farsi migliore”: il prezzo dello sviluppo, specie se disgiunto da un autentico progresso civile, è insostenibile e, di conseguenza, intollerabile.
Il mio amore per il centro storico e per il litorale di Sabaudia, lo so bene, è un amore funereo. Quello che entrambi offrono, infatti, è uno spettacolo di rovine, talora perfino di morte. Sebbene gli edifici del primo siano sempre gli stessi da decenni, sebbene la fisionomia del secondo si conservi pressoché intatta. Certo, la moda, la normativa per la sicurezza, l’affermarsi di nuove attività commerciali, l’erosione della costa, la necessità di ampi parcheggi, la crescita del numero degli stabilimenti balneari, hanno un poco ridisegnato profili, prospettive, angoli e linee. Tuttavia, la Sabaudia che fa mostra di sé in una fotografia in bianco e nero appesa a una colonna sotto i portici e la Sabaudia che si offre al mio sguardo in un limpido mattino di giugno sono sostanzialmente identiche. Perché, allora, la sua vista evoca in me uno spettacolo che possiede il sapore della consunzione, del passato più lontano?
Perché la misura espressa dall’architettura urbana del centro di Sabaudia e la natura incontaminata e, direi, padrona di sé, che contraddistingue questa porzione del litorale laziale, sono oramai destinate a diventare memoria, pagine di libro, immagini in movimento, uguali a quelle che ritraevano Pasolini un anno prima della sua scomparsa. La mondializzazione degli anni Novanta, infatti, ha chiarito in maniera inequivocabile due cose. La prima è che è la dismisura – e dunque l’eccesso, l’accelerazione, la sovrabbondanza – a costituire il paradigma della condotta degli individui, fino al punto da coinvolgere il loro vissuto, il loro esistenziale. La seconda è che la natura, ogniqualvolta entra in gioco il profitto, neppure più viene presa in considerazione, neppure più, cioè, si valuta l’impatto che può avere su di essa un’economia predatoria interessata esclusivamente al mantenimento del perverso ciclo di produzione-consumo-scarto. Il passo indietro nell’accordo sul clima sottoscritto a Parigi nel dicembre 2015 è lì a confermarlo.
La bellezza di Sabaudia, questa è la verità, è una bellezza autoreferenziale e anacronistica, e la stessa cosa potrebbe dirsi di alcuni borghi della Toscana e dell’Umbria. Autoreferenziale, perché parla solamente di sé, perché non è né simbolo né frammento né segno di qualcos’altro di più vasto o di più generale. Sabaudia, infatti, o che si tratti di buona amministrazione o che ciò sia imputabile alla buona sorte, riesce a comunicare al visitatore il sentimento che è ancora possibile amare un’esistenza ispirata al principio delfico del katà métron (“secondo misura”), il quale altrove è stato spazzato via da un’incessante tendenza all’oltrepassamento, all’illimitato, allo sconfinato. La sua bellezza, però, è anche anacronistica, dal momento che preservare ciò che è natura e paesaggio, anziché farli scadere a livello di materia manipolabile e sfruttabile per fini meramente economici e del tutto indifferenti all’etica (e al decoro), è una scelta che si pone in contrasto (e al di fuori) con l’imperativo della cultura contemporanea, che Zygmunt Bauman ha efficacemente riassunto nel motto lapidario “se puoi farlo, devi farlo”.
Sotto questo aspetto, visitare Sabaudia, restare alcuni giorni a Sabaudia, equivale a vivere al confine di due mondi: il mondo di ieri e il mondo di oggi, il mondo contraddistinto dall’amore per il piccolo e il familiare e il mondo definito dall’ebbrezza per il vasto e per il sempre nuovo, il mondo della misura e il mondo della dismisura. Con la triste consapevolezza che per il primo, alla lunga, non può esserci salvezza. È solo una questione di tempo. La violenza del mare che erode la costa è nulla se messa a confronto con quella del capitalismo planetario e del potere della civiltà dei consumi, la quale, se anche risparmia gli edifici e i palazzi, cambia però in profondità le persone. E Pasolini lo aveva perfettamente inteso.