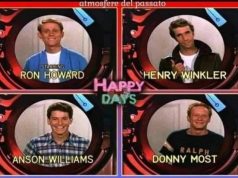La legge Delrio aveva un unico e neppure troppo celato obiettivo: ridurre drasticamente, a colpi di fusioni, il numero dei comuni italiani affinchè grandi comuni andassero a sostituirsi nello scacchiere istituzionale alle province, ed in sostanza, recitassero, nei rapporti con le Regioni, il ruolo svolto fino a quel punto da quest’ultime. Obiettivo, questo, mai dichiaratamente professato ma di evidenza lapalissiana. Un colpo mortale al territorialismo in funzione di un nuovo gigantismo.
Era diventato, tutto un tratto, come spesso accade nel nostro Paese, di moda, scagliarsi, con mani di forbice, contro qualcosa o qualcuno divenuto d’improvviso di troppo, l’immagine plastica dell’inefficienza, dello spreco, lo scalpo da consegnare ad una società civile che reclamava con forza riforme contro la casta e risposte per ridare slancio ad uno Stato bloccato, barocco, elefantiaco e paralizzato dall’austerity.
Manca, come sempre, organicità nel nostro Paese, la capacità di guardare lontano, di pianificare, costruire e prevedere gli effetti di riforme frastagliate e che peccano dell’assenza di una visione di paese nel futuro.
D’altronde era il 2014 e di lì a poco si sarebbe navigato col vento in poppa del 40% alle europee; erano gli anni della rottamazione imperante, dei selfie, proprio come adesso, e delle riforme annunciate ed immaginate su carta e su twitter (anche questo, per la verità, come adesso) servite sul piatto del dover semplicemente e superficialmente tagliare tutto, in fretta e ad ogni costo, ingigantire, ingrandire, allontanare inesorabilmente i centri decisionali dai territori e dai loro cittadini.
La storia degli anni successivi non ha mantenuto le attese e soprattutto ha tradito le speranze dei suoi padri fondatori; si è messa di mezzo la carta costituzionale e quel rango costituzionale al quale le province sono elevate e che ha permesso loro, con il fallimento del referendum, di guadagnarsi una seconda vita tutta da scrivere.
Ci si sono messi di mezzo i territori sempre con più forza e con numeri maggiori, da nord a sud, a dire di no, con forza, a progetti di cancellazione dei loro comuni ammantati e promossi con la promessa di cascate di denari pubblici a compensare e lenire la perdita di municipalità millenarie e con scenari e benefici futuri tutti da verificare.
Si è messa di traverso la storia e le prime avvisaglie di quello che sarebbe accaduto e stava accadendo, di come, ed inesorabilmente, la nuova architettura istituzionale del nostro Stato non aveva fatto i conti con la realtà e con i cittadini e forse anche con la storia e la cultura del nostro paese.
In tutto ciò l’incredibile ed incomprensibile costruzione delle nuove province o meglio di quel poco che ne sarebbe dovuto rimanere: non ci sono ma si eleggono, non dai cittadini ma dai sindaci e consigli comunali del territorio, non hanno più risorse ma presidenti e consiglieri a titolo gratuito e soprattutto competenze mantenute inalterate su settori nevralgici e di primaria importanza. Insomma un pasticcio che doveva durare il tempo di un referendum e che rischia, invece, di vivere e lottare in mezzo a noi per anni ed anni ancora.
Per farsi un’idea di quello che è stato e di quali siano stati gli effetti si consiglia vivamente di armarsi di santa pazienza, di una macchina resistente agli urti, e di incamminarsi in una delle tante strade che solcano la provincia italiana: buche, frane, interruzioni, segnali di pericolo consunti dal tempo sono le cartoline più felici ed il risvolto fausto di ponti che crollano, voragini che si aprono all’improvviso ed un senso di insicurezza che tutto pervade; un’immagine di abbandono non degna di una grande nazione come l’Italia e soprattutto l’amara constatazione che lo status quo potrebbe perdurare per sempre. Nessuno può intervenire, non ci sono le risorse per intervenire e soprattutto non è chiaro di chi sia effettivamente la competenza.
O se preferite visitate uno degli edifici scolastici che ospitano qualche istituto superiore, magari al sud o in qualche provincia italiana meno “cool”; avrete la prova di un’abdicazione voluta ma forse fino in fondo non prevista di ciò che in uno stato come il nostro dovrebbe essere al primo posto tra le priorità, se non altro per ridurre il solco che è stato scavato negli anni rispetto alla gran parte dei paesi europei. Al contrario le scuole versano in condizioni di abbandono e di disagio, senza un disegno strutturale né sulla sicurezza e la riqualificazione degli edifici né tantomeno sul rilancio dell’offerta didattica. Ma questo è un altro discorso.
Ci si è spinti fin qui in nome del risparmio. Ecco, sì, il risparmio, E quanto e cosa abbiamo risparmiato a valle di questa operazione. Vi è da dire che non abbiamo più presidenti, assessori e consiglieri provinciali retribuiti. E su questo si alzerà un hurrà di giubilo dal pubblico. Qualcuno ha mai provato a fare i conti. Se non li avete fatti cominciate adesso e vi renderete conto di quanto i costi della componente politica incidevano sul totale dei costi delle istituzioni provinciali. Nulla praticamente, o almeno pochissimo rispetto al totale. In un bilanciamento costi benefici abbiamo rinunciato gaudenti al governo di un ente territoriale ed all’esercizio, di fatto, delle sue competenze, per sbandierare di aver tagliato le poltrone ma di aver risparmiato nulla, praticamente. Un po’ poco forse.
E se a questo aggiungiamo l’impossibilità di far fuori con un colpo di spugna i dipendenti provinciali alla stessa stregua della componente politica, e la necessità, in fretta e furia, di ricollocarli e di reinventarli presso le regioni, ci rendiamo conto che il dirlo è stato molto più facile del farlo.
E così i Sindaci da soli sono divenuti ancor più soli, le loro competenze si sono amplificate a dismisura, le risorse a disposizione praticamente ormai inesistenti; in questo risiko emerge con evidenza come il nuovo ruolo di gestione attribuito di fatto alle regioni mal si adatta ad enti che per conformazione e strutture sono inclini alla pianificazione territoriale ma non certo alla risoluzione dei problemi quotidiani dei comuni e dei loro abitanti.
E’ naturale che qualcosa debba essere fatto poiché nessuno, memore del 4 marzo, per i prossimi decenni vorrà avventurarsi in una riforma costituzionale e dunque alle province va restituita vita, vanno riassegnate risorse e personale e soprattutto devono ritrovare una mission.
Da più parti si stanno levando cori in questa direzione; l’ultima, almeno per il nostro territorio, la lettera appello di quattordici sindaci senesi che chiedono il ritorno all’elezione diretta per le province.
E’ di ieri l’uscita di Salvini e la sua constatazione sulla necessità di rimettere le mani sulle istituzioni provinciali. Vedremo come andrà e come la prenderanno i suoi alleati di governo, da sempre ultras nei confronti del de profundis di questi enti.
Un cosa è certa: la responsabilità di governo impone, o dovrebbe farlo, scelte che guardino lontano e che immaginino il futuro di un paese o di un territorio, cercando di plasmare il consenso verso gli obiettivi che si vogliono raggiungere e non facendosi indirizzare in funzione del consenso stesso e del suo mantenimento. E’ questione di responsabilità, prima di tutto, e di coraggio di assumere posizioni che, gioco forza, non potranno attirare la totalità ad un unisono applauso ma che dovranno portare con loro lo sforzo e la grandezza della visione. Altrimenti produciamo mostri.