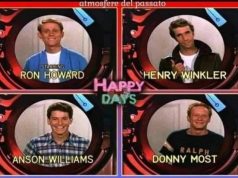Esistono nel dibattito e nella pratica politica odierna due visioni dell’Italia totalmente diverse, agli antipodi l’una dall’altra.
Due modelli di convivenza civile, di assetto istituzionale, ma anche due modelli economici, sociali e culturali in contrapposizione tra loro.
Gli studiosi di politologia le definirebbero “cleavage”, cioè solco, divisione, spaccatura tra due modi di intendere il Paese, l’uno all’insegna del centralismo e di stampo aziendalista, l’altro del policentrismo e della difesa dei beni comuni.
Un taglio secco tra due diversi modelli di Paese, che mette le cose nettamente da una parte o dall’altra, in coerenza tra loro all’interno di ognuna delle visioni in campo.
Sul piano degli assetti istituzionali da una parte sta la concezione tendenzialmente presidenzialista delle istituzioni centrali – compreso un presidenzialismo “di fatto” caratterizzato dalla preponderanza del ruolo del Presidente del Consiglio e del Governo rispetto al Parlamento – ma anche la proposta di costituzione delle macroregioni, lo spostamento verso le regioni di funzioni amministrative (sottratte ai livelli inferiori) e il contestuale tentativo di svuotarle di quelle legislative a vantaggio dello Stato.
Sta una legge elettorale che affida alle dirigenze nazionali dei partiti la determinazione della composizione del Parlamento, in partite elettorali che si giocano soprattutto al centro del sistema.
Scendendo verso il basso l’ampliamento del ruolo e delle disponibilità finanziarie delle città metropolitane, la cancellazione (tentata) e lo svuotamento (riuscito) delle province, le fusioni dei comuni, comprese quelle imposte di fatto o per legge, i tagli finanziari indiscriminati agli enti locali.
Sul piano dei servizi pubblici – cioè acqua, rifiuti, trasporto pubblico locale – da questa parte sta l’ampliamento degli ambiti di gestione, con l’obiettivo di costruirne di livello regionale e chissà un domani magari macroregionale, e la promozione della nascita di grandi società di erogazione che dovrebbero garantire efficienza in quanto… sempre più grandi.
Tutto ciò nell’idea che la chiave per rendere più efficienti i servizi pubblici sia quella di produrre utili da reinvestire o da destinare alla remunerazione dell’intervento dei privati.
Ma anche riforme socio-sanitarie accentratrici che accorpano, ingigantendole, le Aziende Sanitarie Locali, e riorganizzano i relativi servizi tenendo conto dei bacini demografici e dimenticando invece quelli geografici, con la conseguenza di accentrare risorse verso i centri urbani di maggiori dimensioni e di desertificare quelli periferici.
Ma dalla stessa parte sta anche il modo in sui si gestiscono progetti come quelli dell’Alta Velocità ferroviaria, con il suo tagliare fuori di netto dal servizio intere comunità periferiche, usando però al contempo i relativi territori per il passaggio dell’infrastruttura, senza prevedere investimenti per le diramazioni locali delle direttrici principali.
Ed anche la chiusura degli uffici postali nei piccoli centri, che spesso si accompagna a quelli bancari. Da questa parte del fronte sta l’idea di fondo che anche nei servizi pubblici possa farla da padrone il principio aziendalista delle economie di scala, del “più grande è, meglio è”.
Una concezione dello Stato e della politica che tende a limitare i luoghi decisionali e partecipativi, muovendo dall’assunto che uno dei problemi del Paese sia “l’eccesso di democrazia”, cioè l’essere in troppi a dover decidere. Invece dall’altra parte stanno cose diametralmente opposte.
Il rafforzamento del ruolo del Parlamento, l’idea che le Regioni debbano legiferare ma non amministrare, perché l’amministrazione spetta ai comuni.
Sta il ritorno alle province elettive con la relativa attribuzione di risorse e competenze, la lotta per la difesa e la valorizzazione del ruolo dei piccoli comuni quale presidio democratico sul territorio e primo centro di erogazione dei servizi, nonché quale fattore di identità delle comunità locali.
Sta la promozione di una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliersi i propri rappresentanti, magari con veri candidati di collegio, in piccoli collegi, che debbano realmente rendere conto ai territori del proprio operato.
Sul piano dei servizi pubblici locali sta la riappropriazione da parte degli enti locali, e dunque dei cittadini, di un ruolo effettivo nel controllo della loro erogazione, promuovendo il riavvicinamento dei servizi alle comunità locali attraverso la riduzione dell’ampiezza degli ambiti di gestione degli stessi
Nell’idea che la qualità dei servizi pubblici non si misuri sulla base degli utili prodotti, bensì sulla capacità di garantirne efficienza ed universalità.
Ma anche una riorganizzazione del servizio sanitario che tenga conto delle peculiarità delle aree montane, rurali e periferiche, dentro una rete diffusa di erogazione dei servizi socio-sanitari che garantisca a tutti i cittadini parità di diritti a prescindere dal luogo in cui vivono.
Il rafforzamento del trasporto ferroviario locale, con investimenti che vadano ad integrare quelli realizzati sulle direttrici che collegano le città, per raggiungere anche i piccoli centri e garantire il collegamento tra loro e con le realtà urbane.
La difesa dei servizi postali e bancari anche nelle piccole realtà con l’intervento, ove necessario, delle finanze pubbliche.
Da questa parte della barricata sta l’idea che le logiche aziendalistiche nei servizi pubblici non siano sufficienti, e che occorra dunque intervenire con investimenti pubblici dove il mercato non arriva, al fine di mantenere i centri di erogazione quanto più possibile in prossimità dei cittadini.
Nonché la convinzione, in nome della difesa del principio democratico, che la riduzione dei luoghi della decisione politica e la limitazione della partecipazione dei cittadini siano un male.
Da una parte c’è dunque una visione centralistica ed aziendalistica dell’Italia, che pensa i localismi come un freno allo sviluppo, e che pare quasi voler saltare a pie’ pari le molteplici varietà geografiche, culturali e sociali del Paese per fare dell’Italia un unico grande monolite lanciato nell’iperspazio della globalizzazione.
Una visione che dipinge i territori periferici come un luogo dove trascorrere le vacanze, i fine settimana, da ammirare per le loro caratteristiche ambientali e paesaggistiche, ma non come posti dove vivere e lavorare, perché farlo significherebbe accettare inefficienze e diseconomicità.
Un approccio concettuale che può finire per produrre nei fatti una sorta di spinta verso un neourbanesimo, un lento e inesorabile trasferimento di popolazione della zone rurali verso i centri urbani.
Dall’altra la visione invece di un Italia policentrica, che riconosce quelle varietà sia come un fattore identitario che come un motore di sviluppo economico e sociale, e che ritiene che la mano pubblica debba intervenire per garantire servizi adeguati, e dunque qualità di vita, anche nell’Italia rurale, periferica, montana (che è poi la più parte), dove le sole logiche di mercato non bastano a salvaguardare i beni comuni.
E che crede che nelle zone rurali, periferiche e montane si possa e si debba vivere e lavorare.
Sono due idee di Italia che non stanno oggi al centro del dibattito di questa nuova campagna elettorale, forse perché, pur se con sfumature diverse, i partiti nazionali hanno tutti mediamente sposato le ragioni del neocentralismo.
Lo fanno perché sono composti soprattutto da classi politiche cittadine che, in un contesto di limitatezza delle risorse pubbliche nazionali, tendono a promuovere lo spostamento verso le città delle poche risorse a disposizione, cioè laddove risiedono i loro principali bacini elettorali.
Ma nonostante i tentativi di abbatterla, come quelli perpetrati attraverso la cancellazione delle province ad elezione diretta, le fusioni dei comuni o anche con i tagli alle indennità, c’è ancora una classe politica locale, fatta soprattutto da amministratori – Sindaci, assessori, consiglieri – che invece, laddove riesca ad emanciparsi dalle logiche politiche nazionali e ad unire le proprie forze alle migliori energie sociali che emergono dalle comunità locali, può contrastare questa tendenza.
Può farlo in nome dei bisogni, degli interessi e della storia dei territori, promuovendo l’idea di un Italia policentrica e ad energia diffusa.
L’Italia delle tante Italie.