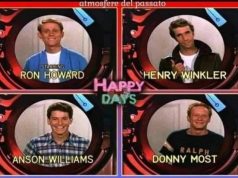Cento anni dalla Grande Guerra. La guerra delle trincee e delle cime innevate, del Piave che mormorava, del ta-pum ta-pum ta-pum. Il centenario riapre dibattiti sulle responsabilità di quella “inutile strage” che contò 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti e mutilati tra militari e civili. Aldo Palazzeschi nel suo libro dedicato alla seconda guerra (Tre imperi… mancati) così parlò della prima, ricordando la fine di luglio 1914: «[fummo] sorpresi dalla notizia più inaspettata e incredibile: la guerra, la guerra di cui avevamo solo letto nella storia e nelle cronache, che ci era apparsa una cosa irreale e irrealizzabile, una cosa d’altri uomini e d’altri tempi, in cui leggenda e fantasia avevano lavorato la loro parte, una fiaba di cui si poteva parlare soltanto con un profumo di mistero e di paura […]». Ma anche tra i letterati qualcuno prese molto sul serio la favola. Impressionante lo scritto di Giovanni Papini (“Amiamo la guerra”, Lacerba, ottobre 1914) in cui si legge che «Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura». Già meglio la retorica di Piero Jahier, patriota senza patria, che dichiara di rischiare la morte non per immedagliate glorie, ma solo per stare accanto a «questo popolo digiuno / che non sa perché va a morire».
Cento anni dalla Grande Guerra. La guerra delle trincee e delle cime innevate, del Piave che mormorava, del ta-pum ta-pum ta-pum. Il centenario riapre dibattiti sulle responsabilità di quella “inutile strage” che contò 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti e mutilati tra militari e civili. Aldo Palazzeschi nel suo libro dedicato alla seconda guerra (Tre imperi… mancati) così parlò della prima, ricordando la fine di luglio 1914: «[fummo] sorpresi dalla notizia più inaspettata e incredibile: la guerra, la guerra di cui avevamo solo letto nella storia e nelle cronache, che ci era apparsa una cosa irreale e irrealizzabile, una cosa d’altri uomini e d’altri tempi, in cui leggenda e fantasia avevano lavorato la loro parte, una fiaba di cui si poteva parlare soltanto con un profumo di mistero e di paura […]». Ma anche tra i letterati qualcuno prese molto sul serio la favola. Impressionante lo scritto di Giovanni Papini (“Amiamo la guerra”, Lacerba, ottobre 1914) in cui si legge che «Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura». Già meglio la retorica di Piero Jahier, patriota senza patria, che dichiara di rischiare la morte non per immedagliate glorie, ma solo per stare accanto a «questo popolo digiuno / che non sa perché va a morire».
Ma ancora più istruttivo è andare a leggere il Giornale di guerra e di prigionia del sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda. Testimonianza diretta e denuncia dell’incompetenza con cui venne condotta la guerra, delle terribili condizioni dei soldati. Era infatti evidente un disordine oggettivo del reale, un non-senso che viene raccontato anche nel romanzo di Emilio Lussu Un anno sull’Altipiano: «Sentivo delle ondate di follia avvicinarsi e sparire. A tratti, sentivo il cervello sciaguattare nella scatola cranica, come l’acqua agitata in una bottiglia». Altrettanto drammatiche, nonostante lo sforzo di trasfigurazione messo in atto dall’autore, risultano le pagine di Giorni di guerra di Giovanni Comisso, che cerca di non assistere alla fucilazione di un disertore dicendo «non volevo vedere di più e mi precipitai dall’altra parte della collina, impastoiato nei passi, sul punto di cadere a ogni istante, sperando di arrivare in tempo per non sentire». Crudezza e ferocia che Corrado Alvaro cerca di rivestire con tenerezza nei versi dedicati A un compagno «mi seppellirono con tanta / carne di madri in compagnia». D’altra parte, per concludere con Ungaretti, tale era il modo per scontare la morte vivendo.
A distanza di un secolo non è, dunque, così scandaloso porsi la domanda su quale tragico colpo di sonno abbia avuto la ragione.