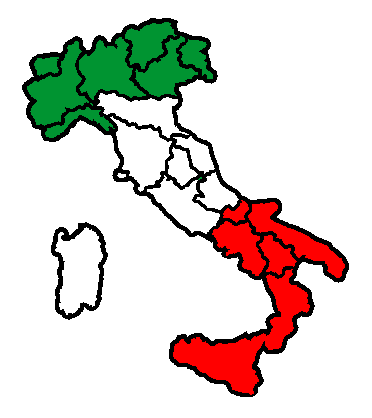Il dibattito su lingua e dialetti sta diventando una battaglia politica, e in quanto tale un bel teatrino (ovviamente dialettale) che dai circoli di paese giungerà a calcare il palcoscenico sanremese dell’Ariston. Infatti, dopo 60 anni, al festival della canzone italiana potranno partecipare interi brani scritti in lingue locali. Come dire: il profumo delle rose di un ormai lontano “Grazie dei fior” incrocerà quello più casereccio di “polenta e osèi”. Sarà dunque il caso di prepararsi al peggio. Amiamo troppo la canzone popolare e dialettale per tollerarne imitazioni (se tali saranno) inevitabilmente kitsch.
Ma per tornare al vero nocciolo della questione, ciò che appare paradossale è fare dei dialetti e della loro indiscutibile ricchezza culturale un’arma secessionista, agitata in nome di una identità di cui a nessuno è chiesta la rinuncia. Una lucida analisi di questi temi apparve mesi fa sulle pagine del Corriere della Sera, laddove Paolo di Stefano portò proficuamente a sintesi il pensiero in proposito dello storico letterario Giulio Ferroni, il quale sostiene che la grande letteratura non può essere campanilista: nemmeno quel filone di poesia dialettale novecentesca che scelse sì il dialetto, ma in quanto “lingua pura per eccellenza, in contrasto con la lingua della comunicazione consumata dai media”. Una sorta di latte di Eva, dice altrimenti Zanzotto, che “non ha niente a che vedere con il dialetto usato oggi in certa narrativa, un colore locale, un idioma banalizzato che ha aspetti di espressionismo soltanto esteriore, un uso superficiale e di maniera”. Già Pasolini, molti anni fa, ci aveva avvertito che il ritorno del dialetto “è una piccola trovata che non ha riscontro nella realtà”. Non lasciatevi ingannare – raccomandava lo scrittore friulano – da cinema, farse e canzonette che sembrerebbero riscoprire il nostro patrimonio folcloristico. Tutto ciò “è un fatto irrilevante: riguarda la sovrastruttura, non la struttura della società. Il dialetto e il mondo che lo esprimeva non esistono più”.
Lasciamo dunque perdere l’insegnamento a scuola dei dialetti. Operazione peraltro impossibile se pensiamo alle molteplici varietà espressive praticate in ogni idioma. I micronazionalismi, anche quelli linguistici, sono fuori dal tempo. Badiamo, piuttosto, a usare bene una lingua condivisa, senza magari dimenticare (praticandolo nei luoghi e nei contesti che ci sono familiari) il parlato dei nonni, che, state certi, domani (con noi e nonostante noi) potrà ancora trasformarsi “contaminandosi”, chissà, con quali altre parole del mondo.
Tempo lettura: 2 minuti