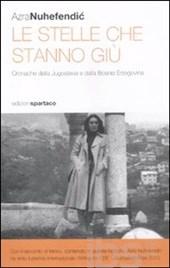 E dunque, in primo luogo mi viene da ringraziare la casa editrice – la Spartaco di Santa Maria Capua Vetere – che ha proposto questo piccolo grande libro: ennesima conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che un’editoria piccola ma coraggiosa ci fa respirare l’aria di un mondo più vasto. In secondo luogo mi viene da ringraziare il libraio di una delle mie librerie predilette – l’Ora Blu di Firenze – che questo libro me l’ha messo tra le mani con la più incoraggiante delle frasi: prova a leggerlo, non te ne pentirai. In terzo luogo, mi viene da ringraziare l’autrice, Azra Nuhefendic, che con il suo “Le stelle che stanno giù”, mi ha dimostrato che c’è ancora spazio per una scrittura che sa insieme essere testimonianza, reportage, denuncia, narrazione elegante e partecipata.
E dunque, in primo luogo mi viene da ringraziare la casa editrice – la Spartaco di Santa Maria Capua Vetere – che ha proposto questo piccolo grande libro: ennesima conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che un’editoria piccola ma coraggiosa ci fa respirare l’aria di un mondo più vasto. In secondo luogo mi viene da ringraziare il libraio di una delle mie librerie predilette – l’Ora Blu di Firenze – che questo libro me l’ha messo tra le mani con la più incoraggiante delle frasi: prova a leggerlo, non te ne pentirai. In terzo luogo, mi viene da ringraziare l’autrice, Azra Nuhefendic, che con il suo “Le stelle che stanno giù”, mi ha dimostrato che c’è ancora spazio per una scrittura che sa insieme essere testimonianza, reportage, denuncia, narrazione elegante e partecipata.
Azra è una giornalista bosniaca musulmana, che ai tempi ha lavorato per la tv di Belgrado e oggi vive a Trieste. Nelle sue cronache – ma è riduttivo chiamare cronache, quasi fossero lavori destinati al consumo di un giorno – ci racconta la Jugoslavia – il paese che c’era prima – e quindi la Bosnia Erzegovina nel mezzo dell’orrore sopportato anche in prima persona. Ciò che è successo, come le cose sono cominciate e cosa ne è disceso, perché una guerra non si conclude mai solo con il cessate il fuoco.
Azra cerca ragioni, indaga sugli scheletri negli armadi, insegue parabole di vita, si interroga prima di tutto su ciò che è stato della sua vita, al crocevia come una delle grandi tragedie del Novecento. Riepiloga terribili nefandezze, ma sa anche commuovere con giganteschi lampi di umanità, raccontando per esempio di quei “nemici” serbi, che nei giorni più duri, l’hanno nascosta, protetta, sfamata (un popolo è sempre al plurale, ci sono volti, nomi, storie, persone come un vicino di casa che ti può consegnare oppure salvare).
Parla di cimiteri che ora dividono le comunità anche da morti, in un paese dove prima era comune accendere una candela per un’icona ortodossa, passare da una chiesa cattolica e poi condividere una preghiera con i musulmani. Parla di una lingua che prima era uguale per tutti e ora è il croato per i croati, il serbo per i serbi, il montenegrino per i montenegrini, il bosniaco per i bosniaci, con i linguisti al servizio dei nazionalisti per inventarsi ridicoli neologismi e gli interpreti chiamati per i primi incontri ufficiali dopo la guerra. Parla del treno tra Sarajevo e Belgrado che per diciott’anni non c’è più stato e delle altre linee, delle altre strade che sono state interrotte – Ci costringevano a stare in territori sempre più piccoli, dentro confini sempre più stretti, a non muoverci, a interrompere i contatti non solo fisici ma anche mentali, finché la rottura non fu completa, fino a che l’isolamento non si trasformò in assedio – non senza rammentare con nostalgia i treni della vecchia Jugoslavia socialista, che i giovani della sua generazione prendevano d’estate, per andare al sud, al mare: affollati, lenti, arroventati dal sole, ma anche carichi di un’idea di futuro che doveva essere per forza diverso.
Cimiteri, parole, treni: quante cose in questo libro. Quanti campanelli d’allarme da far funzionare, sempre e comunque. Quanta umanità di cui far tesoro in un mondo che non ha smesso di essere difficile.




